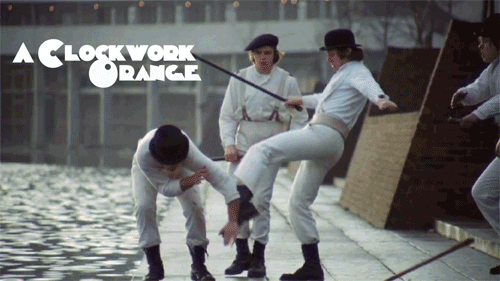La prigioniera
La prigioniera (La prisonniere) è l’ultimo film diretto dal maestro George Henry Clouzot nel 1968, il congedo di un grande regista con un grande film.
Clouzot cala il sipario sulla sua carriera di cineasta a otto anni dal grandissimo successo di La verità e a quattro dall’incompiuto L’enfer; un decennio, quello degli anni sessanta, che vede Clouzot più alle prese con i problemi personali che con il cinema, con una serie di funesti avvenimenti come la morte dell’amatissima moglie, una lunga depressione e infine l’infarto che lo coglie durante la lavorazione di L’enfer.
La prigioniera quindi nasce in un periodo in cui pare che finalmente il regista francese abbia ritrovato entusiasmo e ispirazione; ed infatti il film sarà un vero e proprio sunto della sua arte cinematografica in cui appaiono evidenti i frutti del lunghissimo lavoro di sperimentazione compiuto proprio con L’enfer, il film rimasto allo stato embrionale e di cui per quarantanni si erano perse le tracce della lavorazione.Che sono riaffiorate qualche anno addietro grazie a 180 bobine recuperate da Serge Bromberg a casa della vedova di Clouzot Ines e che testimoniano lo straordinario lavoro di preparazione per quel film del quale parlerò in un prossimo post.

Sono proprio gli esperimenti fatti con L’enfer a trovare applicazione in La prigioniera; scatti arditi, intensi primi piani, luci psichedeliche ecc.mostrano come Clouzot fosse riuscito ad inventare un nuovo sistema visivo e comunicativo che il regista stesso applica a primi piani tormentati ed espressivi,ossessivamente ripetuti e che mostrano le varie espressioni degli artisti impiegati e che raccontano una storia fatta di perversione e passione, di raffinata morbosità di un menage a trois che solo per un caso non sfocerà in una tragedia.
La storia che Clouzot racconta in fondo non ha molta importanza se non nell’ottica dell’uso di questo nuovo linguaggio meta visivo:ancora una volta sono i tormenti a farla da padrone, la gelosia e il possesso, gli oscuri meandri della psiche umana eviscerati e mostrati attraverso il linguaggio proprio della psiche, che non può essere lineare per ovvi motivi ma che rappresenta un incubo per immagini.

Se nell’Enfer il soggetto era l’ossessione al limite della follia di un uomo per sua moglie, in La prigioniera il concetto è ampliato ed esteso ad un triangolo fatto da una donna e due uomini.
C’entra l’amore, c’entra il desiderio di possesso, c’entra anche la morbosità del desiderio inconscio proprio della donna di entrare nel masochistico inferno dell’amante, del quale condividerà e sperimenterà la sottile perversione e il desiderio di possesso globale, inglobante a cui la donna sfuggirà per puro caso.
Siamo a Parigi; Gilbert e Josè sono una coppia moderna, di quelle aperte a qualsiasi esperienza legata però da un sentimento d’amore molto forte che tiene unita la coppia stessa aldilà delle tentazioni fortissime provenienti dall’esterno del mondo che loro faticosamente sono riusciti a costruire.
Lei lavora nel campo dell’immagine e si occupa di un documentario entre lui è uno scultore d’avanguardia e questo loro essere presenti nel mondo dell’arte li porta una sera alla mostra del fotografo Stan Hassler.Grazie ad un invito di quest’ultimo Josè ha modo di visionare i suoi scatti ed uno in particolare la turba profondamente,una donna nuda e in catene.Nei giorni successivi Josè scopre di essere attratta e contemporaneamente disgustata dalla foto e quando casualmente incontra nuovamente Stan che le chiede un passaggio e poi la invita ad assistere ad una serie di scatti che sta per fare Josè accetta.

Nell’attesa della modella Stan usa Josè per le prove luci e da quel momento per Josè inizia un incubo al quale però non saprà sottrarsi,anzi.Tra Stan e Josè inizia una relazione in cui l’uomo utilizza la sua forza di volontà per legare a se in modo masochistico la donna,mostrando di volere un totale dominio su di lei. Josè,ormai succube si abbandona a lui salvo tentare in seguito, ormai innamorata senza speranza di quell’uomo dagli impulsi auto distruttivi, di liberarlo dalle sue manie.
Ma Gilbert,che è innamorato di sua moglie, non accetta di essere messo da parte e da quel momento la storia prende una direzione che sembrerebbe portare ad una tragedia annunciata ma che invece…
Non svelo assolutamente il finale perchè è una perla incastonata in un’altra:un film così affascinante correva il rischio di avere un finale scontato, sia in senso drammatico sia in senso happy end.Clouzot sceglie una strada a sorpresa che dona al film invece la patente di capolavoro.

Siamo di fronte quindi ad un film rigoroso nella ricerca continua,spasmodica da parte del regista dell’inquadratura,dello scatto e della sequenza che mostri la via attraverso il labirinto delle sensazioni di Josè, un’esplorazione in cui si rischia di perdersi in partenza ma in effetti è proprio il perdersi la cosa che affascina di più.
Il gioco a tre assume contorni sfumati in funzione proprio dell’analisi dei sentimenti, delle psicologie;se tutto alla fine rimane irrisolto è perchè l’animo umano e la sua psiche divergono perchè uniche e apartenenti ad ogni singolo individuo.E’ il concetto di umanità ad essere esaltato, nella sua parte più oscura, più unica.Se L’Enfer era stato un viaggio nella follia che purtroppo non abbiamo potuto fare, con La prigioniera facciamo un viaggio metafisico per immagini e alla fine ci ritroviamo si al punto di partenza ma abbiamo avuto comunque la possibilità di sondare e toccare qualcosa di indefinito e magico.

Per buona fortuna Clouzot ottiene il meglio dagli attori scelti per l’indagine:Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener, Bernard Fresson, Dany Carrel, Monique Lange, Darío Moreno, Marcel Moussy, Michel Etcheverry lavorano ottimamente anche se ovviamente Elisabeth Wienernel ruolo di Josè,Laurent Terzieff in quella di Stanislas Hassler e Bernard Fresson in quella di Gilbert Moreau hanno la possibilità di emergere maggiormente grazie ai ruoli principali a loro assegnati.
Grande lavoro di Andréas Winding alla fotografia, vivida e dagli effetti pop/psichedelici che impreziosiscono il tutto rendendo l’atmosfera ottico/visiva un’esperienza unica.
Un film quindi imperdibile, purtroppo trasmesso rarissimamente in tv mentre in rete è presente solo in versione originale.
La prigioniera
Un film di Henri-Georges Clouzot. Con Dany Carrel, Bernard Fresson, Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener Titolo originale La prisonnière. Drammatico, durata 105′ min. – Francia, Italia 1968
Laurent Terzieff : Stanislas Hassler
Bernard Fresson : Gilbert Moreau
Elisabeth Wiener : José
Dany Carrel : Maguy
Claude Piéplu : il padre di José
Noëlle Adam : la madre di José
Dario Moreno : Sala
Daniel Rivière : Maurice
Regia Henri-Georges Clouzot
Sceneggiatura Henri-Georges Clouzot, Monique Lange e Marcel Moussy
Fotografia Andréas Winding
Montaggio Noëlle Balenci
Scenografia Jacques Saulnier
L’opinione di mck dal sito http://www.filmtv.it
(…) Una diapositiva fra le altre tra le altre si espone come infra-fotogramma / intra-frame subliminale che, ” pre ’68 “, scatena una reazione di difesa dall’imbarazzo [ stiamo parlando della Rivoluzione Sessuale, che quella Artistica è Sempre in atto e in scena, mentre come Tabù si è passati dal Sesso alla Morte, che la scienza ancora non ‘basta’, quando la Rivoluzione Industriale, dopo quella democratica-repubblicana che ha partorito anche nazismo…nazionalsocialismo…fascismo…comunismo, ha accelerato-catalizzato l’evoluzione esponenzialmente ] : una risata ( ” che stupida, è un fatto nervoso, scusami, non sono riuscita a trattenermi, mi dispiace / non lo hai fatto apposta ? posso rivederla ? ” – che l’ultimo tango a parigi sarebbe giunto a breve…) tra ” Rien ” ed ” Être ” ://: dal costruttivismo all’estetica della cinetica, passando per la fattografia…, da Duchamp, Vasarely, Rodchenko…, a DeSade e Majakovskij ://: l’ossimoro non tale del Film Industriale ( dall’uscita dalle officine Lumière, istant-mockumentary, a Vertov, da Méliès a Brakhage, da Chaplin ad Ejzenštejn, da Kubrick ad Olmi-Antonioni ), “ovvero” la riproduzione in più copie della Realtà più vera del vero, bigger than life, contrapposta alla Cinema-Fo-toGrafia come Industria : l’astratto concreto dell’edificio macchinario suppellettile soprammobile, arte in serie, l’anti/senza carne, sesso, amore, sentimento, comprensione, condivisione E linguaggio vs Nouvelle Vague ( il contratto sociale, la vita amorosa di Tuffaut/Rohmer, il Personale è Politico, la mente fisico-storica di Resnais/Godard, e viceversa…) : il Contatto che cerca Josée ( una raggelata, fiammeggiante É. Wiener che, come la C. Aubry di Manon in seguito interpreterà solo altri 2-3 film “importanti” ma non “memorabilissimi” ed in parte prescindibili : e ancora come lei ( i loro personaggi ) affronterà un calvario, qui con esito sospeso in freeze-frame sui titoli di coda, là s/terminata nella Promised Land Gitaiana ), la dolce sua preoccupazione per l’essere in ritardo all’appuntamento con Stan ( un Laurent Terzieff che ricorda un mix di DeAndrè-Malkovich-Tenco-Dafoe-Gainsbourg-Walken ), la vergogna ed il coraggio insieme durante il primo set-sho(o)t di pose da “giornalista” vs la moderna relazione col compagno ( Bernard Fresson artista “ma” in parte…-…alla fine geloso, ed in toto alla fine…”generoso”…innamorato ) basata sul poter fare tutto — doversi dire raccontarsi confessarsi EWS tutto.(…)
L’opinione di emmepi8 dal sito http://www.filmtv.it
Ultimo film di Clouzot, regista francese molto particolare, che qui ha sfiorato a basso volo la censura, almeno per quei tempi. Dopo qualche anno di silenzio riappare, ma finisce il film in extremis, coadiuvato da una altro regista, Robert Menegoz. Un film spinoso che affronta un argomento morboso che è quello della del masochismo. Clouzot ha dovuto fare i conti con gli anni, nel senso che il progetto non ha avuto la piena appartenenza, comunque c’è da riconoscere, un apertura mentale non indifferente, anche se i temi trattati da lui sono sempre stati “malati”. La morale grida vendetta, ma deve fare i conti con gli animi degli uomini che sono sempre alterabili ed irrazionali, De Sade sta di casa qua. Operazione non facile, ma che prende coraggiosamente le sue conseguenze, peccato che l’attrice protagonista non è l’ideale giusta per un ruolo complesso come questo. Ottime riprese ed ambientazione che ancora oggi mantiene intatto il suo valore.
l’opinione di notoriusnicky dal sito http://www.filmscoop.it
Ultimo film di Clouzot, i tempi delle atmosfere noir, gialli zeppi di suspance sono materia recisa da tempo, questo è un Clouzot che ci lascia approfondendo ancor di più la psicologia malata dei suoi soggetti, protagonisti che col decorso della carriera da carnefici son diventati autolesionisti, compulsivamente attratti dal desiderio di suicidio (‘La verità’ 1960), recuperando una tematica cara al tanto accostato Hitchcock, il ‘voyeurismo’ dell’artista indotto a plasmare il corpo umano, denudarlo di ogni dignità, sodomizzarlo (in quel periodo tematica assunta anche dal nostrano Bava), la vittima persuasa dall’alone di mistero più che dal compenso economico, ne rimane attratta sentimentalmente ma non corrisposta, il suo è un masochismo per far piacere all’altrui persona, coppie aperte (siamo in piena rivoluzione sessuale), e psicologia del colore (eccede con virtuosismi farraginosi, siamo nel ’68 ed è naturale accostarlo al trip di ‘2001’).
Scevro da ogni forma di didascalia analitica sulla psiche umana, è una parabola sulla fertilità dell’amore, e cosa ti porta a fare per ottenerlo, simile alla Bardot de ‘La verità’ almeno in quanto a bellezza, la Wiener, non in termini di dissolutezza recitativa (non pensavo di arrivare a rimpiangere una Bardot pur brava a gestire le sue armi di seduzione ma che il più delle volte sono poste come contraltare ad una espressività lacunosa)
L’opinione di Saintgifts dal sito http://www.davinotti.com
Clouzot dà l’addio all’attività di regista con questo film per me straordinario. Straordinario nella tecnica, con scene che emozionano, che siano in interni o in un porticciolo o su di uno scoglio. Con un uso del colore ben studiato ed effetti psichedelici notevoli. L’argomento poi è importante e trattato in modo da non farlo mai scadere nel banale o peggio nel più superficiale dei voyerismi, merito anche di un Terzieff e di una Wiener in stato di grazia. È comunque di amore che si parla e dell’universo femminile, mai abbastanza sondato e capito.
L’opinione di Giuan dal sito http://www.davinotti.com
Commiato “hors categorie” per il regista più controverso del cinema francese. Fin dal titolo “proustiano” è un film in cui riecheggia il clima claustrofobico e morboso tipico dello stile di Clouzot, contrappuntato però dalla ricerca di opzioni tecniche altre, con cui raccontare patologie allora poco dicibili, ma alfine riconducibili alle dinamiche tra i sessi. Variazione originale sul tema del triangolo nel quale l’occhio e la visione hanno parte preponderante. Resta apppiccicato addosso e rimane in mente. Wiener e Terzieff emanano un fascino malato.
L’opinione del sito http://www.nocturno.it
(…) La rappresentazione dei giochi mentali che formano l’ossatura del rapporto sadomasochista che prende corpo tra i due (ma anche del matrimonio falsamente “aperto” di Josée e Gilbert) è quanto di più acuto e inquietante il cinema avesse rappresentato fino a quel momento. Clouzot costruisce tutto il film sul non visto, sulla suggestione, sulla dimensione tutta cerebrale dell’erotismo: come nella scena in cui Stan insegna a Josée a dominare verbalmente un’inesistente terza persona, con la mdp che segue i movimenti dell’immaginaria schiava nella stanza vuota, o con l’ellissi che ci porta dal momento in cui Josée arriva al primo appuntamento fotografico al “dopo” in cui la donna contempla le immagini scattate dall’uomo con protagoniste lei e un’altra modella. Una scelta rigorosa, e non certo dettata da pudicizia. Dirà Clouzot: «Si j’avais fait du sadique un SS, tout le monde aurait admiré ça. Si j’avais fait le strip-tease mais que ce soit celui de Salomé devant le roi Hérode on aurait souri aimablement. Ce qui est très gênant c’est quand on met un miroir en face de la figure et qu’il faut s’y reconnaître». La prisonnière è gelido come un teorema nel condurre in porto l’assunto iniziale: è anche crudele e profondamente misantropico, come lo erano stati Il corvo, Vite vendute, I diabolici, al punto di trasformare impercettibilmente il carnefice in vittima, e viceversa, mostrando la labilità dei ruoli sessuali. L’ansia borghese di normalizzare i propri impulsi, trasformando un’ossessione erotica in un’accettabile infatuazione amorosa con annessa fuga romantica, trasforma Josée nel polo dominante della coppia, mentre Stan si scopre davvero innamorato, ma anche indifeso e umiliato nella propria impotenza.Resta da dire della forma: di rado si è visto un film così felicemente audace, così coerente e inesausto nella sperimentazione visiva e sonora. Al suo primo film a colori, Clouzot batte i figliocci della nouvelle vague sul loro stesso terreno, componendo ogni inquadratura come un piccolo trattato sui significati emotivi degli elementi cromatici, isolando chiazze di colori primari e utilizzando le illusioni ottiche create dalle opere degli artisti ottico-cinetici in mostra presso la galleria di Terzieff per ricostruire un universo affascinante e ipnotico, sonorizzato dalle muische di Berio, Webern, Xenakis. Se, come dice Terzieff, «l’arte moderna corrisponde esattamente al mondo di oggi, aiuta a capirlo pur essendone un riflesso», il mondo di La prigioniera è un riverbero ormai indecifrabile del nostro inferno mentale, un labirinto in cui ognuno è prigioniero dei propri demoni, visualizzato in un prodigioso tour de force onirico finale che richiama il trip psichedelico di Keir Dullea in 2001.
La sposa in nero
In una stanza anonima una donna è seduta su un divano; sfoglia con nervosismo un album di vecchie foto, mentre accanto a se ha una valigia aperta e piena di indumenti.Ad un tratto la donna si alza di scatto e apre la finestra; sembra intenzionata a lanciarsi nel vuoto ma una signora anziana la trattiene.
La chiama Julie,teneramente.
Julie completa la sua valigia e prende con se molte banconote.
La ritroviamo all’uscita di una stazione, diretta verso un condominio lussuoso.
Qui chiede informazioni su Bliss, un disinvolto don Giovanni che però al momento è assente.
Nel pomeriggio Bliss annuncia,durante un party nel suo appartamento, le prossime nozze con una donna ricchissima; è avvicinato da Julie, che è riuscita ad entrare perchè è talmente elegante, affascinante e misteriosa da non suscitare alcuna remora da parte del padrone di casa.
Claude Rich (Bliss) e Jeanne Moreau (Julie)
Una meravigliosa Jeanne Moreau interpreta Julie
Che ovviamente non perde tempo nel tentare di agganciare quella misteriosa donna.
Mentre sono sul balcone dell’appartamento, Julie fa cadere volontariamente la sua sciarpetta oltre il balcone; Bliss cavallerescamente si offre per andare a riprenderla ma appena scavalca il parapetto viene spinto giù dalla donna, che contemporaneamente gli dice ” ‘Sono Julie Kolher‘ “.
Julie, approfittando della confusione, si eclissa e va all’aeroporto, dove prende un aereo, con destinazione la casa di Coral.
Julie lascia a casa dell’uomo un biglietto invito per l’opera, dove la sera si incontreranno. Stregato dalla bellezza e dalla sensualità magnetica della donna, Coral accetta di invitarla a casa sua il giorno dopo.Qui Julie arriva l’indomani con un disco e una bottiglia di liquore; Coral inizia a parlarle del suo passato mentre Julie ascolta impassibile.La donna ha avvelenato il liquore che Coral ha bevuto così quando l’uomo inizia a mostrare i primi sintomi dell’avvelenamento, Julie racconta di essere vedova dal giorno delle sue nozze, quando un colpo di fucile uccise suo marito sul sagrato della chiesa. Julie assiste impassibile alle disperate richieste di aiuto di Coral,ormai morente; subito dopo gli ultimi spasmi dell’uomo raccoglie le sue cose, pulisce le tracce della sua presenza e si allontana.
La morte di David, marito di Julie
Raggiunta una stazione, Julie raggiunge un’altra località; qui, con un espediente, si sostituisce alla tata del figlio di Clement Moran, un politico di una certa rilevanza.
Dopo una serie di avvenimenti, Julie riesce a rinchiudere Clement Moran in un ripostiglio ed è in questa occasione che apprendiamo nuovi particolari sulla vita di Julie e sul ruolo che hanno avuto le due vittime precedenti ( e di conseguenza su quello di Moran) nella morte del marito della donna.
L’uomo, con un gruppo di amici, si era ritrovato sbronzo come loro dopo una giornata di bevute e di gioco a carte in un appartamento; qui avevano fatto un gioco stupido e pericoloso, avevano cioè puntato la folla nelle strade con un fucile fino a quando, tragicamente, era partito il colpo fatale che aveva ucciso il marito di Julie.
La donna,freddamente, racconta all’uomo del suo amore per il marito, che aveva sognato di sposare fin da bambina,Dopo di che, sigilla il ripostiglio con del nastro adesivo e lascia soffocare l’uomo, che verrà rinvenuto cadavere il giorno dopo.
Ritroviamo Julie in una chiesa.
Ad un sacerdote racconta quello che ha commesso, certa dell’obbligo al silenzio del prelato; subito dopo si mette sulle tracce di Delvaux, l’uomo che, secondo il racconto di Moran, ha materialmente sparato al marito.
Ma sulle tracce di Delvaux, uomo rozzo e incolto, molto differente dalle vittime precedenti, c’è anche la polizia, che lo arresta per aver venduto un auto di provenienza dubbia.
Julie è così costretta a modificare i suoi piani e decide di mettersi sulle tracce di Fergous,un pittore che era presente nella famigerata stanza nel giorno tragico della morte di suo marito; presentatasi come modella, Julie riesce a far perdere la testa al pittore, che l’ha immortalata nella posa di Diana cacciatrice e che le ha fatto un superbo nudo. Un amico di Fergous crede di riconoscere Julie, ma è troppo tardi: la donna uccide con una freccia il pittore e si dilegua, sempre dopo aver fatto sparire le sue tracce.Ma questa volta sembra commettere un errore madornale. Lascia il quadro che la ritrae nuda e si reca ai funerali di Fergous, dove viene riconosciuta. Arrestata, confessa senza remore i suoi quattro omicidi.
Julie nei panni di Diana…
Julie in realtà non ha commesso un errore fatale. Infatti…
Una trama complessa, da noir puro per un film straordinario, degno della migliore trazione francese di questo particolare genere.Un film da vedere assolutamente, questo di Francois Truffaut; il grande regista parigino, morto prematuramente a 52 anni, nel pieno della sua maturità artistica e culturale, disegna un personaggio quello di Julie, destinato a restare impresso indelebilmente nella memoria dello spettatore.
Julie è una donna fondamentalmente fedele al suo sogno di ragazza, quello del principe azzurro e dell’amore “per tutta la vita”; quando il suo sogno si spezza, per una tragica fatalità, si trasforma in una macchina da guerra letale, una macchina che persegue senza remore ed esitazioni l’oscura volontà di una vendetta senza mediazioni.
Non c’è nulla che possa fermare la donna che cammina sui sentieri bui di una vendetta che non fa distinzioni fra il reale assassino di suo marito e gli involontari complici.Per lei l’essere stati presenti nella stanza fatale è già una condanna a morte, diretta e senza appello.
Il secondo omicidio…
Una donna con un’ossessione fatale, cinque uomini della classe medio borghese e una vendetta terribile e puntuale; Truffaut si muove tra queste due situazioni mostrando il gelido piano messo in atto dalla donna (con tanto di sorpresa finale) e le figure tutto sommato meschine degli uomini che lei giustizia, ognuno affetto da un principio di megalomania.Il playboy,l’uomo che non riesce a conquistare le donne, il politico, il pittore che ama le donne e per contraltare il brutale e rozzo sfascia carrozze non ispirano alcuna simpatia.
E’ proprio Julie il personaggio per cui si parteggia, una donna che ha perso lo scopo della sua vita, come lei stessa confessa al politico Moran; possiamo non capire la sua sete ossessiva di vendetta, ma parteggiamo ugualmente per lei.
Truffaut, seguendo con abilità il tema dell’omonimo romanzo giallo di Cornell Woolrich che nel libro si firmò William Irish, disegna un film tecnicamente perfetto, mostrando più di un tributo ad Alfred Hitchcock, vero maestro del noir.
L’opera è praticamente esente da pecche e sopratutto ancor oggi appare fresca e affascinante; se può sembrare assurdo il comportamento di una semplice donna di provincia che si trasforma in un’implacabile serial killer, occorre pensare ai giorni nostri, a tutti quei delitti misteriosi che spessissimo altro non sono che il frutto delle gesta di gente semplice che all’occorrenza trova dentro di se motivazioni per compiere gesta tragiche.
Charles Denner e Jeanne Moreau in una foto di scena
E che spesso riesce a farla franca, pur non avendo esperienza nel campo.
Il film dicevo non ha praticamente pecche; su tutto va ricordato il ruolo fondamentale della stupenda, affascinante Jeanne Moreau, la Julie del film, che presta la sua glaciale e impenetrabile bellezza ad un personaggio memorabilmente interpretato.
L’attrice parigina, oggi ottantacinquenne, quando interpreta il film ha quarant’anni esatti; è una donna dalla bellezza statuaria, concentrata sopratutto su un volto misterioso e dai tratti finissimi.Un’autentica bellezza, che qui viene esaltata ancor più da un personaggio enigmatico, quella Julie che per certi versi finisce per diventare tutt’uno con lei.
Il resto del cast fa egregiamente il suo lavoro, al servizio della vera star del film stesso, la stupenda Moreau.
La sposa in nero (La mariée était en noir) è quindi un film da non perdere assolutamente, un film intrigante e affascinante, un noir che avvince e che tiene con il fiato sospeso.
Un film che non ha avuto molti passaggi televisivi ma che è facilmente reperibile in rete.

La sposa in nero
Un film di François Truffaut. Con Michael Lonsdale, Jean-Claude Brialy, Michel Bouquet, Jeanne Moreau, Alexandra Stewart Titolo originale La mariée était en noir. Drammatico, durata 107′ min. – Francia 1968.
Jeanne Moreau: Julie Kohler
Claude Rich: Bliss
Jean-Claude Brialy: Corey
Michel Bouquet: Coral
Michael Lonsdale: Morane
Charles Denner: Fergus
Daniel Boulanger: Delvaux
Serge Rousseau: David
Christophe Bruno: Cookie
Alexandra Stewart: Melle Becker
Jacques Robiolles: Charlie
Luce Fabiole: la madre di Julie
Sylvie Delannoy: signora Morane
Regia François Truffaut
Soggetto dal romanzo La sposa era in nero (The Bride Wore Black) di William Irish
Sceneggiatura François Truffaut e Jean-Louis Richard
Casa di produzione Les Films du Carrosse, Les Productions Artistes Associés, Dino De Laurentiis Cinematografica
Fotografia Raoul Coutard
Montaggio Claudine Bouché con l’assistenza di Yann Dedet
Musiche Bernard Herrmann
Scenografia Pierre Guffroy
Nella vita bisogna sempre pretendere quel che c’è di meglio, non bisogna mai arrendersi.(Jule)
La giustizia degli uomini è impotente a punirmi: io sono già morta. Sono morta lo stesso giorno in cui è morto David. Lo raggiungerò quando l’avrò vendicato.(Julie)
Lei crede di vendicarsi, ma sbaglia: non ci si può vendicare . degli uomini, non si finirebbe mai. Bisognerebbe vendicarsi non solo dei loro delitti, ma anche della loro ignoranza, di quasi tutti i loro pensieri.(Il sacerdote, rivolto a Julie)
Qualcuno ha detto: non esistono ottimisti né pessimisti, soltanto imbecilli allegri e imbecilli tristi.(Julie)
In fatto di solitudine sono un esperto. (Coral)
Mi piace molto la volgarità, nelle donne, perché le rende vive. (Fergus)
Sa come si dice? Quando il bicchiere è pieno lo vuoto, quando invece è vuoto lo compiango.(Coral)
“Lei è bella, troppo bella.” -Perché troppo?- “Troppo bella per me.” (Coral rivolto a Julie)
 Il romanzo di Woolrich da cui è tratto il film
Il romanzo di Woolrich da cui è tratto il film
Una delle splendide locandine del film
Francois Truffaut
Il regista,Francois Truffaut
La merlettaia
Beatrice, una ragazza bella ma timida e discreta, ha una vita normale: lavora presso un parrucchiere come apprendista e vive un’esistenza senza sussulti accanto a sua madre.
La sua amica Marylene, lasciata dall’amante, la convince a fare una vacanza a Cabourg, in Normandia e qui Beatrice conosce Francois, uno studente affascinante figlio di una nobile famiglia.
Tra i due l’amore è improvviso e travolgente e da quel momento trascorrono le vacanza sempre insieme.
Ma anche il breve periodo di relax volge al termine e i due devono ritornare alle loro esistenze così differenti;
nonostante il parere opposto delle rispettive famiglie, i due giovani innamorati decidono di andare a vivere assieme e per qualche tempo l’amore che li unisce sembra essere tanto forte da superare le barriere sociali e le convenzioni.
Ma dopo poco tempo Francois si stanca del legame e decide di lasciare la ragazza che accetta a capo chino la decisione dell’uomo, lascia l’appartamento e riprende la monotona esistenza precedente.
Ma qualcosa in lei si è rotto per sempre.
Beatrice si ammala gravemente di anoressia e in preda a turbe psichiche finisce per essere internata in un ospedale psichiatrico.
Ed è li che Francois la raggiunge e ……
La merlettaia ( o La dentelliere nell’edizione francese, The lacemakers in quella inglese) prende il suo titolo da uno dei quadri più belli di Jan Vermeer ed è un film diretto da Claude Goretta nel 1977.
Il regista elvetico, specializzato in sceneggiati tv, gira un film malinconico e triste con un finale virato al pessimismo imbastendo una storia d’amore sullo sfondo delle evidenti contraddizioni tra sentimento e ragione, tra realtà amara e sogni disillusi.
Beatrice è una ragazza del proletariato, con un’esistenza tranquilla e anonima, una delle tante esistenze che si consumano all’ombra della capitale francese.
E’ una ragazza come tante, quieta e sognatrice, timida e tranquilla che in fondo non sogna altro che avere un lavoro e trovare un giorno il grande amore.
Francois è all’opposto uno studente proveniente dall’aristocrazia parigina, ricco e viziato, che ignora ovviamente l’esistenza di routine del proletariato parigino non per colpa sua, ma semplicemente perchè la vita gli ha dato un ruolo sociale ben preciso e un’esistenza dorata e senza problemi.
I due mondi, paralleli e antitetici non potrebbero incontrasi mai, differenti e distanti come sono ma a fare da trait d’union c’è un sentimento, ovvero qualcosa che alle volte travalica convenzioni e regole sociali.
Ma il sentimento più antico e profondo, ovvero l’amore, ha delle regole precise: deve essere bilaterale e totale per poter abbattere secoli di convenzioni sociali, deve essere profondo ed assoluto.
In realtà Francois è solamente infatuato della sensibile Beatrice e per lui la relazione non è altro che un momento di distrazione, un’avventura come tante. Nonostante Beatrice sia la donna dei sogni di qualsiasi uomo, tenera ed appassionata com’è, il frivolo Francois sembra non cogliere gli aspetti pregnanti della psicologia della ragazza. I suoi discorsi e la bieca motivazione che addurrà per lasciare la fragile Beatrice mostrano come il rapporto tra i due in realtà sia stato visto come qualcosa di grande e assoluto solo dalla ragazza, che possiede sentimenti profondi a differenza del suo compagno.
Non sarà infatti tanto la differenza di classe sociale a distruggere il rapporto quanto la noia e il desiderio di andare oltre di Francois, espressione classica di un ceto sociale arrogante e privo di valori, privo fondamentalmente di quel sentimento che Beatrice possiede per due ma che non può in alcun modo colmare il divario esistente nella coppia.
L’amore è il sentimento supremo, ma non è la bussola universale evidentemente; così alla passione che Beatrice mette nel rapporto, al suo amore così profondo Francois risponde con le convenzioni sociali e la rigidità delle regole che puntellano il suo mondo, creando le premesse per una tragedia che puntualmente si verificherà quando la ragazza vedrà i suoi sogni andare in fumo.
Si può morire, per amore, e Beatrice questo farà delusa dal suo amante che in fondo altro non è che un bambino viziato e sconfitta da una società che ha delle regole precise e invalicabili.
Quando la dolce ragazza comprenderà che il suo è stato un sogno breve, avrà la forza di analizzare anche il contesto in cui tutto è avvenuto e si renderà conto che in fondo tutto ciò che ha vissuto aveva un epilogo scritto nelle premesse.
La favola di Cenerentola è quello che è, una favola e le favole nella vita quotidiana non esistono.
Goretta dipinge un quadro che assomiglia in modo impressionante all’originale pittorico di Vermeer; nel quadro la giovane ricamatrice è il soggetto principale ed assoluto, lavora in un luogo disadorno ed è il centro focale del dipinto, che illustra la cura e la meticolosità con cui il soggetto affronta il suo lavoro e Beatrice altro non è che un’apprendista di un lavoro altrettanto umile, una parrucchiera di umili origini.
I due volti, quello della merlettaia di Vermeer e quello di Isabelle Huppert, splendida interprete del film, possono quasi sovrapporsi prima di prendere le strade che ognuna delle due prenderà Della merlettaia del dipinto abbiamo colto un attimo, un frammento della sua vita sospeso in eterno. Di lei non sappiamo nulla, non sappiamo chi è, da che famiglia viene, sappiamo solo che ricama con estrema attenzione. Di Beatrice alla fine conosciamo tutto, dalla sua profondità di sentimenti fino alla sua fragilità psichica, quella fragilità che la condurrà ad un triste destino.
Perchè lei è incapace di accettare un ruolo che altri hanno disegnato : il suo amore dovrebbe spezzare le catene ma le catene si riveleranno impossibili da scalfire e questo segnerà la sconfitta non solo dell’amore di Beatrice ma anche la fine dei sogni e l’irruzione prepotente di una realtà in cui i sogni muoiono all’alba.
La merlettaia è un film bellissimo e triste. Con diverse chiavi di lettura in cui lo spettatore può addentrarsi se vuole e parteggiare per una tesi invece che a favore di un’altra (l’amore impossibile, le differenze sociali ecc.) oppure può semplicemente lasciarsi andare e osservare una storia che delicatamente racconta l’impossibilità della realizzazione di un sogno o di una favola.
Goretta traccia una storia quasi normale, vista al cinema molte volte e nella vita reale ancor di più con un linguaggio poetico di rara bellezza ed equilibrio.
Era facile cadere nella trappola del vittimismo, dipingendo Beatrice come un’eroina sfortunata ed era altrettanto facile dipingere la società parigina aristocratica e superba come un coacervo di antichi vizi e scarse virtù.
Il regista svizzero non fa nulla di tutto questo e ci consegna un dramma lineare nel suo percorso interpretato splendidamente da quella grande attrice che è Isabelle Huppert, che regala attimi intensi ogni qualvolta presta il suo volto magicamente malinconico ad un personaggio indimenticabile come quello di Beatrice.
In fondo La merlettaia è anche una grande prestazione d’autore, in cui un ottimo regista,Goretta ed una bravissima attrice, la Huppert, esprimono il meglio del loro talento al servizio di una pellicola che finisce per diventare indimenticabile.
La merlettaia è un film quasi invisibile nelle programmazioni televisive, per cui consiglio caldamente ai lettori di questo blog di cercarlo in rete o in qualche versione dvx, che sono tratte da fonti digitali (il film è da tempo disponibile in dvd) e che quindi riescono a restituire l’aria di malinconica bellezza che il film stesso ispira.
La merlettaia
Un film di Claude Goretta. Con Isabelle Huppert, Yves Beneyton, Florence Giorgetti, Michel De Ré, Jean Obé, Monique Chaumette, Annemarie Düringer, Renata Schroeter Titolo originale La dentellière. Drammatico, durata 108′ min. – Svizzera 1977.
Isabelle Huppert: Beatrice
Yves Beneyton: François
Florence Giorgetti: Marylène
Annemarie Düringer: Beatrice
Sabine Azéma: Corinne
Michel de Ré … Il pittore
Monique Chaumette …La madre di François
Jean Obé … Il padre di François
Regia Claude Goretta
Soggetto Pascal Lainé
Sceneggiatura Claude Goretta e Pascal Lainé
Fotografia Jean Boffety
Montaggio Joële Van Effenterre
Musiche Pierre Jansen
Scenografia Claude Chevant e Serge Etter
Filmscoop è su Facebook: richiedetemi l’amicizia.
Il profilo è il seguente:
http://www.facebook.com/filmscoopwordpress.paultemplar

Vi prego di dedicare pochi secondi per rispondere al sondaggio che segue:le vostre opinioni sono importantissime!
Il padrino
Quando i dirigenti della Paramount, la grande casa di produzione cinematografica americana fondata da Zukor acquisirono i diritti del romanzo di Mario Puzo Il padrino non immaginavano certo che avrebbero incontrato tante difficoltà per ridurre il romanzo stesso prima in una sceneggiatura e poi in un film sul quale aveva deciso di scommettere con molta audacia.
La genesi di una delle opere cinematografiche più famose della storia, che ebbe anche due sequel e che si trasformò contemporaneamente in una delle saghe più belle della storia del cinema e in un’operazione commerciale di straordinario successo, è quanto di più complesso si possa immaginare.
Robert Evans, il capo indiscusso della Paramount chiamò alcuni registi famosi offrendo loro di dirigere il film con un budget notevole, segno che la casa di produzione credeva fermamente nel progetto.
Marlon Brando
Inaspettatamente registi del calibro di Sergio Leone, Elia Kazan, Arthur Penn e Costa Gavras declinarono gentilmente l’invito; il genere mafia movie era ancora considerato poco appetibile e fondamentalmente dequalificante per un regista di fama, così l’incredulo Evans dopo aver scartato il grande Peckinpah, che voleva libertà d’azione ma che aveva anche problemi gravi a livello psicologico (abusava di farmaci e whisky) puntò su Francis Ford Coppola, un regista praticamente sconosciuto che aveva alle spalle solo 4 film peraltro diretti in un arco temporale di 8 anni.
La scelta dell’attore protagonista si rivelò ancora più difficile; Coppola ovviamente voleva fare a modo suo mentre i vertici della Paramount avevano idee differenti.
Alla fine la spuntò Coppola, che dovette scontrarsi con collaboratori e dirigenti; in effetti la scelta di Marlon Brando era molto rischiosa in quanto il grande attore di Omaha non aveva certo l’età per interpretare il patriarca della famiglia Corleone, Don Vito.
Alcune sedute di trucco e dell’ovatta infilata nella bocca trasformarono Brando nella maschera divenuta poi celebre.
Altrettanto laboriosa fu la scelta del resto del cast; per il ruolo di Michael, figlio di Don Vito, si scatenò una vera guerra tra il regista e la produzione.
Ma Coppola, per sua e nostra fortuna difese a spada tratta le sue scelte e chiamò l’illustre sconosciuto Al Pacino per ricoprire il ruolo delicatissimo di Michael.
L’attore di New York aveva all’attivo solo un paio di partecipazioni, la seconda delle quali era stata quella in Panico a Needle Park; Coppola testardamente andò avanti e completò il cast con Robert Duvall,James Caan, Diane Keaton e con gli altri attori che grazie al successo di Il padrino ebbero una visibilità internazionale senza precedenti.
Come sappiamo, il film fu un successo assolutamente straordinario, tanto che il film vinse tre Oscar su 11 nomination (Miglior film, Miglior attore protagonista per Marlon Brando, Migliore sceneggiatura non originale per Francis Ford Coppola e Mario Puzo), si aggiudicò 4 Golden Globe e in Italia due David di Donatello.
Tutto il mondo applaudì un film tecnicamente perfetto splendidamente recitato e appasionante come pochi.
Avvenimento più unico che raro, Il padrino fu salutato da larga parte della critica come uno dei film più importanti della storia del cinema, cosa poi amplificata negli anni successivi dalla costruzione di un mito che vede il film di Coppola come una delle opere imprescindibili della cinematografia di tutti i tempi.
Ma quali sono i meriti effettivi del film di Coppola, perchè ha avuto tanta fama e perchè ha affascinato generazioni di spettatori?
In primis il merito fondamentale va a Coppola, capace di ricavare dal romanzo di Puzo un affresco vivo e affascinante sull’America degli anni 40 (con incursioni nel passato e quindi all’origine del fenomeno della criminalità organizzata), realizzato tramite una storia senza cedimenti e senza pause.
Un film che dura 175 minuti, un’eternità cinematograficamente parlando ma che passano in un lampo, tante e tali sono le situazioni e le storie intimamente collegate che fanno del Padrino il classico film che tiene incollati alla poltrona.
Poi la grandissima resa del cast, che Coppola fortissimamente volle e che rispose con caratterizzazioni rimaste nella storia del cinema, a partire da quella di Marlon Brando che diventò un autentico mito grazie alla maschera di uomo duro, di criminale ma con tanto di codice d’onore.
La mafia uccide, la mafia significa traffici illeciti e tutto il peggio che ciò comporta, ma Don Vito Corleone appare quasi un eroe nella sua capacità di rifuggire quando può dall’uso della violenza. Crede nell’amicizia, nella famiglia e gestisce i suoi affari senza crudeltà inutili.
E’ un malvivente, ma di quelli che riescono anche a suscitare simpatia.
Simonetta Stefanelli
E Brando trasforma il suo personaggio in qualcosa di vivo e pulsante, un personaggio negativo che però ha dei valori che la sua famiglia in qualche modo rispetta e venera.
Accanto a lui si muovono gli altri protagonisti della saga, ovvero il cinico Michael, dapprima riluttante e poi braccio destro fedele del padre e suo vendicatore nonchè suo sostituto alla guida della famiglia.
Al Pacino diventa anch’esso un simbolo e da quel momento diverrà uno degli attori più stimati di Hollywood, tanto da essere in seguito definito uno degli attori più importanti della storia stessa del cinema.
A differenza di Brando, Pacino avrà modo di rinverdire la sua fama anche grazie ai due successivi sequel che porteranno a compimento la saga della famiglia Corleone.
Un altro protagonista importantissimo, anche se in un ruolo leggeremente defilato è Robert Duvall, quel Tom Hagen che è il braccio nell’ombra del Padrino, il figlio adottato che venera Don Vito e che in seguito mostrerà tutto l’affetto per la famiglia Corleone diventando il braccio destro di Michael.
Ancora, c’è James Caan, il figlio prediletto del boss, irruento e così differente dal padre e da Michael e che finirà ucciso coinvolgendo proprio Michael in una guerra che non avrebbe voluto. Bravissimo, Caan, nel mostrare forza e testardaggine; è violento e testone, ribelle ma anche profondamente legato a quel padre che non condivide la sua maniera di gestire gli affari ma che lo adora senza riserve.
Diane Keaton
La famiglia Corleone è composta anche da Connie Corleone, interpretata splendidamente da Talia Shire (Tania Rose Coppola, sorella del regista), la donna che per prima si sposa con l’uomo che tradirà la famiglia e che morirà per ordine di Michael, da Fredo che è il vero punto debole della famiglia.
Fredo è un giovane con qualche problema, timido e privo della forza di carattere che è a caratteristica del padre e dei suoi fratelli; John Cazale, che interpreta Fredo riserva al suo personaggio quell’aria spaurita che sarà la caratteristica peculiare nel secondo film della saga, quando troverà la morte per ordine del fratello Michael.
La famiglia Corleone è questa, ma attorno ad essa ruotano altri personaggi che in un modo o nell’altro finiranno per condividerne le sorti; c’è Kay Adams, compagna di studi di Michael che lo sposerà e gli darà un figlio, interpretata da una bellissima Diane Keaton, c’è Apollonia, prima moglie di Michael, da quesi sposata in Sicilia e morta in un attentato esplosivo.
Apollonia è interpretata dalla bella Simonetta Stefanelli, che resta in scena poco tempo ma che dette vita al personaggio forse più rimpianto dagli spettatori, la giovane e ingenua ragazza siciliana che sposa il suo amore e che finisce per morire in maniera assurda e tragica.
Ci sono ancora tanti personaggi che costellano la storia, ma occorrerebbe uno spazio enorme per descriverli tutti.
Perchè la caratteristica del Padrino è proprio quella di mostrare uno spaccato di vite che ruotano attorno alla famiglia Corleone; dal boss rivale Sollozzo (il trafficante) a Tattaglia, un altro boss rivale passando per Clemenza (amico di Don Vito) e per Carlo Rizzi (il marito di Connie).
Personaggi che si muovono sullo sfondo di una New York malavitosa e violenta, nella quale anche la polizia ha i suoi problemi, tra mele marce come il capitano ucciso da Michael e le tangenti che vengono pagate agli agenti per chiudere un occhio.
Se vogliamo, un altro dei pregi del film è proprio la capacità descrittiva di un ambiente in cui convivono tante realtà in modo precario e in equilibrio instabile; c’è la lotta tra bande, ci sono omicidi per il controllo del territorio e degli affari più loschi mentre si affaccia prepotente il bussines dei bussines, l’affare del secolo ovvero il traffico e lo spaccio della droga.
James Caan
In un mosaico così organico come può mancare una colonna sonora adeguata?
Il motivo portante del film, opera del maestro Nino Rota, è avvolgente e sinuoso e finisce per diventare immediatamente riconoscibile, un autentico marchio di fabbrica che finirà per diventare anch’esso un best sellers.
A ben guardare Il padrino è il più italiano dei film di Hollywood e non solo perchè parla di mafia e di una famiglia italiana.
Coppola è italo americano, essendo figlio di una famiglia di origini lucane, Mario Puzo lo è anche lui perchè la sua famiglia è di origini campane, così come italianissimo è il maestro Nino Rota; di origini italiane è Al Pacino, italo americano è Lombardi che è direttore degli effetti speciali.
Il plot del film è conosciutissimo per cui è perfettamente inutile riassumere una trama che ormai tutti conoscono nei minimi dettagli.
Val la pena invece ricordare che Coppola in fase di sceneggiatura con l’ovvia consulenza di Puzo decise di sveltire la trama del film eliminando alcune cose presenti nel romanzo, come il piano ideato da Don Vito per far rientrare suo figlio Michael dall’esilio siciliano in seguito all’omicidio del Capitano di polizia, la parte dedicata al tormentato matrimonio tra Kay e Michael con la breve separazione tra i due coniugi, il personaggio di Jules, nuovo compagno di Connie e altre parti descrittive giudicate cinematograficamente poco proponibili.


Il Padrino, come dicevo agli inizi, è un affresco grandioso e affascinante; Coppola, dopo il grande successo del film si vide immediatamente proporre un sequel e due anni dopo lo realizzò, centrando un altro successo di portata planetaria.
Il padrino – Parte II (The Godfather: Part II), realizzato nel 1974 non solo si rivelò un successo ma superò come riconoscimenti il film precedente, vincendo 6 Oscar su 11 nomination. Coppola bissò l’Oscar alla regia centrando un record che sarà uguagliato solo da Il signore degli anelli, vincere cioè due Oscar consecutivi con il film pilota e poi con il sequel.
A 16 anni di distanza, nel 1990 venne girata la parte finale della saga, Il padrino – Parte III (The Godfather: Part III) : il film ebbe successo, ma inaspettatamente venne bocciato alla notte degli Oscar, dove su 7 nomination non portò via nemmeno un premio. La giuria scelse come film dell’anno Balla coi lupi, che fece incetta di premi proprio a spese del capitolo conclusivo della saga del Padrino.
Oggi il primo film di Coppola sulla famiglia Corleone è considerato, dall’American Film Institute come il terzo film statunitense più importante della storia, dietro Casablanca e Quarto potere.
Il padrino
Un film di Francis Ford Coppola. Con Marlon Brando, James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton,
Richard Castellano, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni Russo, John Cazale, Julie Gregg, Tony Giorgio, Salvatore Corsetto, Rudy Bond, Cardell Sheridan, Vito Scotti, Angelo Infanti, Alex Rocco, Franco Citti, Richard Bright, Corrado Gaipa, Victor Rendina, Saro Urzì, Simonetta Stefanelli, Jeannie Linero, John Martino, Tere Livrano, Al Martino, Salvatore Corsitto, Ardell Sheridan, Lenny Montana, Morgana King
Titolo originale The Godfather. Drammatico, Ratings: Kids+16, durata 175 min. – USA 1972.
Marlon Brando: Don Vito Corleone
Al Pacino: Michael Corleone
James Caan: Santino Corleone
Robert Duvall: Tom Hagen
Diane Keaton: Kay Adams
Talia Shire: Constanzia Corleone
John Cazale: Fredo Corleone
Richard Castellano: Peter Clemenza
Abe Vigoda: Salvatore Tessio
Sterling Hayden: Mark McCluskey
Al Lettieri: Virgil Sollozzo
Gianni Russo: Carlo Rizzi
Corrado Gaipa: Don Tommasino
Al Martino: Johnny Fontane
John Marley: Jack Woltz
John Martino: Paulie Gatto
Lenny Montana: Luca Brasi
Richard Conte: Emilio Barrese (Barzini)
Alex Rocco: Moe Greene
Salvatore Corsitto: Amerigo Bonasera
Julie Gregg: Sandra Corleone
Simonetta Stefanelli: Apollonia Vitelli
Saro Urzì: Sig. Vitelli
Angelo Infanti: Fabrizio il Pastore
Franco Citti: Calò
Regia Francis Ford Coppola
Soggetto Mario Puzo (romanzo)
Sceneggiatura Mario Puzo, Francis Ford Coppola
Produttore Albert S. Ruddy
Casa di produzione Paramount Pictures
Fotografia Gordon Willis
Montaggio William Reynolds
Peter Zinner
Effetti speciali Paul J. Lombardi
Musiche Nino Rota
Scenografia Dean Tavoularis
Costumi Anna Hill Johnstone
Giuseppe Rinaldi: Don Vito Corleone
Ferruccio Amendola: Michael Corleone
Pino Colizzi: Santino Corleone
Cesare Barbetti: Tom Hagen
Mario Laurentini: Peter Clemenza
Elio Zamuto: Salvatore Tessio
Riccardo Cucciolla: Fredo Corleone
Vittoria Febbi: Kay Adams
Rita Savagnone: Connie Corleone
Gino Donato: Mark McCluskey
Arturo Dominici: Virgil Sollozzo
Michele Gammino: Carlo Rizzi
Sergio Graziani: Jack Woltz
Gigi Reder: Paulie Gatto
Guido Celano: Luca Brasi
Arturo Dominici: Amerigo Bonasera
Donatella Gambini: Apolonnia Vitelli
Incipit del romanzo di Puzo
Amerigo Bonasera sedeva nella III Sezione Penale della Corte di New York in attesa di giustizia; voleva vendicarsi di chi aveva tanto crudelmente ferito sua figlia e, per di più, tentato di disonorarla.
Il giudice, un uomo servero dai lineamenti pesanti, si arrotolò le maniche della toga nera, come se intendesse punire fisicamente i due giovanotti in piedi davanti al banco. Il suo viso esprimeva freddamente un maestoso disprezzo. In tutto questo, tuttavia, c’era qualcosa di falso che Amerigo Bonasera intuiva, ma non comprendeva ancora.
“Avete agito come la peggior specie di degenerati” disse aspramente il giudice. Sì, sì, penso Amerigo Bonasera. Animali. Animali. I due giovanotti, capelli lucidi tagliati a spazzola, viso tutto acqua e sapone in atteggiamento di umile contrizione, chinarono il capo in segno di sottomissione.
Il giudice continuò: “Avete agito come bestie selvagge in una giungla e siete fortunati di non aver abusato di quella povera ragazza, altrimenti vi avrei mandato in prigione per vent’anni”. Fece una pausa e gli occhi sotto le sopracciglia straordinariamente folte ebbero un lampo furtivo verso il volto olivastro di Amerigo Bonasera; poi li abbassò su un cumulo di rapporti mensili di libertà sulla parola che aveva davanti. Aggrottò le sopracciglia e si strinse nelle spalle, come per mostrarsi convinto suo malgrado. Parlò di nuovo.
“Tuttavia, grazie alla giovane età, al fatto che siete incensurati e appartenete a famiglie rispettabili, dato che la legge nella sua magnanimità non cerca vendetta, io con questa sentenza vi condanno a tre anni di reclusione. Condanna con la libertà condizionale.”
– Sonny Corleone: Hai saputo? Il Turco vuole trattare. Bella faccia di corno, quel figlio di puttana! Ieri sera la presa nel culo e oggi vuole trattare.
– Michael Corleone: Cos’ha detto?
– Sonny Corleone: E che deve dì? Piripì, perepè, perepà, perepù; vuole che mandiamo Michael a sentire le sue proposte. E fa sapere che l’offerta sarà così buona, che non potremo rifiutare
Per la giustizia dobbiamo andare da don Vito Corleone.
Quando colpiscono, colpiscono quelli che amiamo.
La droga deve essere controllata come un’industria per mantenerla rispettabile! Non la voglio vicino alle scuole. Non la voglio in mano ai bambini! Questa è un’infamità. Nella mia città limiteremo il traffico ai negri e alla gente di colore. Tanto sono bestie, anche se si dannano peggio per loro.
“Santino… vieni qua! Ma che fai Oh. Il tuo cervello che si è rammollito a furia di correre appresso a quella… a quella li? Mai dire a una persona estranea alla famiglia quello che c’hai nella testa.”
Michael Corleone:”Mio padre non è diverso da qualunque altro uomo di potere, da qualunque abbia responsabilità di altri uomini. Come un senatore, un presidente”
Kay Adams:”Non vedi come è ingenuo quello che dici?”
Michael Corleone:”Perchè?”
Kay Adams:”Senatori e Presidenti non fanno ammazzare la gente”
Michael Corleone:”Chi è più ingenuo Kay?”
Eyes wide shut
Con Eyes wide shut si conclude la carriera cinematografica di Stanley Kubrick.
Il regista di New York naturalizzato inglese dirige il suo tredicesimo e ultimo film che uscirà postumo nel 1999, dopo peripezie durate due anni e una serie interminabile di correzioni apportate dal regista, maniacale come pochi, perfezionista come nessuno.
Quando Kubrick dirige Eyes wide shut sono passati ben dodici anni da Full metal jacket, uno dei capolavori e pietra miliare del cinema pacifista; questa volta Kubrick sceglie di adattare cinematograficamente il romanzo Doppio Sogno (titolo originale tedesco Traumnovelle) di Arthur Schnitzler, scritto nel 1925 ma uscito l’anno dopo in una Germania ormai sotto la cupa e minacciosa dittatura nazista.
Era un vecchio pallino di Kubrick, il romanzo di Schnitzler sin dall’epoca dell’uscita sugli schermi di Arancia meccanica, il film più rivoluzionario di Kubrick e probabilmente quello che più di tutti incarna la sua voglia di sperimentazione, di denuncia, di accettazione e di studio di una società immaginata da Burgess (autore del testo originale A clockwork orange) come votata all’autodistruzione.
Questa volta Kubrick decide di indagare l’inconscio e l’onirico, attraverso un percorso irto di ostacoli nei meandri della mente umana tra coscienza e accettazione della stessa, tra sessualità inespressa e il suo esatto opposto.
Kubrick porta a compimento quindi un lungo cammino, nel corso del quale ha esplorato tutti i confini dell’uomo attraverso il suo rapporto con l’infinito e l’incognito in 2001 Odissea nello spazio, il suo ruolo nella società visto attraverso la violenza che possiede a livello latente e il rapporto con il potere in Arancia meccanica, la follia anch’essa latente che può albergare nella mente umana con contorno di onirico e paranormale in Shining e infine la violenza dura e cruda della guerra, quella che annichilisce anche quello che c’è di buono nell’animo umano di Full metal jacket ( e di Orizzonti di gloria).
Nicole Kidman e Tom Cruise
E’ un’analisi per forza di cose estremamente sommaria e superficiale, questa: non si può di certo ridurre l’opera di uno dei più grandi cineasti di sempre a stereotipi condensati con due aggettivi, ma serve per introdurre l’elemento nuovo che Kubrick porta con questo film.
Questo elemento è un viaggio all’interno del sesso, forse la molla più grande e allo stesso tempo la cosa più intima che l’uomo possegga a livello istintivo ma non solo; il sesso è anche una questione di cervello, è un mistero ed è al tempo stesso un pianeta inesplorato come l’universo di 2001 Odissea nello spazio, nonostante il gran parlare e la sovra esposizione di cui gode l’argomento.
In Eyes wide shut assistiamo alla messa in scena di uno stato dell’essere umano profondo e a tratti inesplorato, almeno a livello personale per molti esseri umani; quali sono gli anelli di congiunzione della sessualità, quali siano le molle che la spingano e cosa siano il fascino indicibile di tutto ciò che riguarda il sesso finiscono sotto la lente di ingrandimento di Kubrick che però deve fare i conti anche con il libro che ha adattato per fare il suo film.
Lui modifica, manipola crea e distrugge, rifà e rifà mille volte, sempre ossessionato dal suo perfezionismo, quello stesso perfezionismo che lo porterà a girare per ben due settimane la stessa scena, quella dell’acquisto di un giornale (come raccontato dal suo assistente Emilio D’Alessandro) e quando alla fine gira l’ultimo ciak ecco che la morte lo coglie nel sonno il 7 marzo 1999, all’età di settant’anni.
La sua morte ci priva di alcune risposte, lasciandoci dubbi e incertezze, gli stessi e le stesse che prova lo spettatore che si mmerge nei 159 minuti del film.
Sono tanti i dubbi, sono tante le sequenze oscure, sono tanti i riferimenti onirici che alla fine ci si smarrisce quasi in presenza di un labirinto costruito appositamente senza uscite.
O forse l’uscita c’è, ma non è visibile e rimane solo nelle intenzioni del regista.

Kubrick racconta le storie parallele e allo stesso tempo intersecate, convergenti di William “Bill” Harford, un medico ricco e benestante e di sua moglie Alice; i due sono ovviamente universi a se stanti, ognuno di essi vive la propria esistenza in maniera indipendente e autonoma fino a quando come coppia devono integrarsi attraverso i complessi meccanismi dell’amore e infine del sesso.
Bill è il primo dei due a sperimentare i desideri inconsci dell’eros, quella sessualità che sembra muovere l’umanità come molla fondamentale all’essere.
Passa attraverso l’incontro con due ragazze che lo abbordano ad una festa alla dichiarazione d’amore della figlia di un suo paziente, dall’incontro con una prostituta con la quale però non consuma alla celebre orgia nel corso della quale assiste ad un’altra messa in pratica del sesso, quella che toglie qualsiasi coinvolgimento emotivo se non quello legato ai sensi e al loro appagamento.
Una vera e propria ginnastica da camera, in cui il sesso è praticato un po come le flessioni per gli addominali: non c’è amore, non c’è un briciolo di qualsiasi sentimento perchè tutto si riduce ad un atto meccanico e gratificante solo nell’istante in cui viene praticato.
Queste esperienze porteranno Bill ad una maggiore consapevolezza dei misteriosi meccanismi che regolano il sesso, anche se c’è da dubitare che lo stesso Bill sia avviato ad una piena consapevolezza di cosa in realtà sia il sesso.
Sua moglie Alice vive invece una situazione diversa.
L’unione matrimoniale con Bill sembra solida, eppure al ballo lei si lascia corteggiare da un misterioso e affascinante uomo ungherese fino a lasciarlo quando il gioco sembra diventare troppo pericoloso.
Quando ne parlerà con suo marito, gli confesserà di averlo tradito anche se solo in sogno con un giovane ufficiale della Marina; per Bill è un’altra tappa sul cammino della conoscenza anche se è ancora troppo confuso per mettere a fuoco la portata di ciò che gli ha rivelato la moglie.
Anche sua moglie ha pulsioni sessuali derivanti da fantasie più o meno consce; in fondo anche se profondamente diversi e culturalmente separati da secoli di disparità sociale, con la donna relegata in ruoli umilianti hanno in comune l’umanità.
Moglie o cortigiana, null’altro.
La sorpresa di Bill nell’ascoltare la confessione della moglie risente proprio di questo retaggio culturale, che sembra quasi improntato nei geni e nel dna dell’uomo.
In fondo per quanto evoluto, l’essere umano non ha perso gli istinti primari dell’animale (il riferimento è alla celebre scena del gorilla che lancia l’osso verso il cielo in 2001 Odissea nello spazio); le nostre origini sono quelle e Bill è il prodotto di quell’evoluzione.
Vedremo Bill ancor più turbato sul finale del film, quando la moglie tornerà sull’argomento e rivelerà al marito di essere stata sul punto di cedere alle sue fantasie e di lasciare suo marito.
A questo punto il discorso di Kubrick si allarga e coinvolge non più soltanto la sfera intima del sesso, ma anche l’istituzione matrimonio, che è uno dei fondamenti della società.
Come è possibile conciliare il desiderio sessuale, le pulsioni del sesso con la relazione monogama di una vita? Come soddisfare il bisogno primario e istintivo del sesso quando si è scelto scientemente di dividere la propria vita con un’unica donna? E questo discorso può anche essere ribaltato dal punto di vista femminile, visto che i ruoli e i comportamenti degli umani in fondo variano solo in funzione di secoli di morale imposta.
Eyes wide shut porta con se tante domande, alcune difficilmente leggibili, alcune senza una risposta univoca, altre assolutamente enigmatiche.
Porta con se anche poche risposte, molte delle quali suggerite ma solo a livello di possibilità, non di certezza.
E’ insomma il Kubrick di sempre, che suggerisce ed esplora ma non si spinge fino a dare soluzioni, risposte.
Quando Bill incontra la prostituta, fa quello che l’uomo compie dalla notte dei tempi, ovvero esercita un potere che sembra essersi attribuito, quello cioè di poter disporre del corpo della donna; avere quindi una patente di possesso che ripristini una specie di legge della natura che vede l’uomo dominante e la donna succube.
Ma questa è la natura ( e solo fino ad un certo punto) del regno animale. Per l’uomo valgono altre leggi, codificate in secoli e secoli di evoluzione.
Così Bill fugge senza aver consumato, forse perchè conscio di compiere un atto da uomo afflitto da problemi più che da uomo consapevole.
E questa chiamiamole morale finisce per essere esplicitata in diversi punti del film, con allegorie e messaggi subliminali che Kubrick si diverte a seminare.
Questo film è complesso, enigmatico, difficile e potrei continuare a lungo con altri aggettivi che però nulla aggiungerebbero al fascino estremo di una pellicola che il grande regista inglese consegna alla storia del cinema con tutto il suo carico pesantissimo di cose non dette.
Se devo esprimere un giudizio personalissimo, non inserirei Eyes wide shut nell’elenco delle cose migliori di Kubrick pur essendo lo standard qualitativo del film di assoluto livello.
Intendiamoci è solo una questione personale.

Il film è raffinatissimo come fotografia, maniacale come ricerca e documentazione oltre che come rappresentazione visiva ma è anche terribilmente gelido e a tratti incomprensibile.
Occorre davvero tanta buona volontà per interpretare alcuni passaggi e c’è anche un problema grave legato al cast.
Se la scelta di Nicole Kidman come interprete del ruolo di Alice appare indovinata, convince assolutamente meno quella della scelta di Tom Cruise (all’epoca marito della Kidman) in quella di Bill.
Occorreva un attore meno hollywoodiano e più intimista, meno patinato e più “umano” per mostrare le mille sfaccettature di un personaggio così complesso che invece alla fine appare quasi impaludato.
Cruise è smarrito, non ha nelle sue corde la drammaticità del personaggio.
Stanley Kubrick in passato aveva già scommesso ( e vinto) quando si era affidato all’esordiente Malcom Mc Dowell per il ruolo di Alex nell’Arancia meccanica o a Ryan O’Neal per quello di Barry nel suo splendido Barry Lindon.
Qua le cose cambiano e la recitazione di Cruise fa calare il risultato finale. Intendiamoci, niente di drammatico o irreparabile, pure l’attore di Syracuse rappresenta il classico granello di polvere nell’ingranaggio perfetto.
In quanto al resto del film, in ordine sparso citerei alcune delle critiche che sono state mosse al film, molte delle quali assolutamente pretestuose.
La più comune è quella di aver decretato il successo del film a priori, quasi che Kubrick fosse in grado di produrre capolavori a scatola chiusa, una sorta di beatificazione anticipata del grande regista.
In realtà chi amava e ama Kubrick sa che le chiavi di lettura dei suoi film sono talmente tante che anche in visioni successive delle sue opere si finisce per gustare un particolare, anche un solo fotogramma che esplica il suo straordinario talento visivo. La cura ossessiva dei dettagli e della fotografia sono anche in questo film uno dei punti di forza dello stesso, così come avvolgente e sinuosa è la colonna sonora che Kubrick utilizza, saccheggiando Liszt e Šostakovič ma non solo.
In quanto all’uso dell’erotismo, le critiche mosse sono addirittura ridicole; nel film di Kubrick il sesso è glaciale, mostrato solo in pose plastiche che esaltano il suo concetto di erotismo come “ginnastica da camera”.

Identico il discorso della celebre orgia, nella quale c’è profusione di nudi che però tutto fanno tranne che eccitare la fantasia dello spettatore. Le attrici appaiono come lontanissime divinità dai corpi scultorei e marmorizzati, quasi non fossero creature umane ma sublimazioni di un’idea.
In definitiva Eyes wide shut è un lavoro affascinante e misterioso, stimolante e imperfetto, splendidamente affrescato quasi fosse un’opera di Michelangelo ed esaltato da una luminosità fotografica che è pari solo a quella di Barry Lindon.
Con questo film Kubrick ci lascia un’eredità fatta da 13 pellicole che in una ipotetica classifica dei primi cento film della storia del cinema sarebbero probabilmente tutte presenti.
Ci lascia anche il rammarico di non poter mai più vedere la realizzazione di uno dei suoi sogni, quel film su Napoleone che sicuramente avrebbe scritto un’altra pagina miliare della cinematografia mondiale.

Eyes Wide Shut
Un film di Stanley Kubrick. Con Nicole Kidman, Tom Cruise, Madison Eginton, Jackie Sawris, Sydney Pollack, Peter Benson, Todd Field, Michael Doven, Sky Dumont, Louise J. Taylor, Stewart Thorndike, Randall Paul, Julienne Davis, Lisa Leone, Kevin Connealy, Thomas Gibson, Jackie Sawiris, Leelee Sobieski, Rade Sherbedgia, Rade Serbedzija, Leslie Lowe, Marie Richardson, Vinessa Shaw, Alan Cumming Drammatico, durata 160 min. – Gran Bretagna, USA 1999
Lee Lee Sobieski
Tom Cruise: Dott. William “Bill” Harford
Nicole Kidman: Alice Harford
Sidney Pollack: Victor Ziegler
Todd Field: Nick Nightingale
Sky Dumont: Sandor Szavost
Marie Richardson: Marion
Vinessa Shaw: Domino
Fay Masterson: Sally
Leon Vitali: Ierofante rosso
Rade Šerbedžija: Sig. Milich
Leelee Sobieski: Figlia di Milich
Thomas Gibson: Prof. Carl Thomas
Alan Cumming: Portiere dell’albergo
Madison Eginton: Helena Harford
Jackie Sawiris: Roz
Leslie Lowe: Illona
Michael Doven: Segretario di Ziegler
Louise J. Taylor: Gayle
Stewart Thorndike: Nuala
Randall Paul: Harris
Julienne Davis: Amanda “Mandy” Curran
Lisa Leone: Lisa
Kevin Connealy: Lou Nathanson
Mariana Hewett: Rosa
Togo Igawa: Uomo giapponese
Regia Stanley Kubrick
Soggetto da Doppio sogno di Arthur Schnitzler
Sceneggiatura Stanley Kubrick, Frederic Raphael
Produttore Stanley Kubrick
Fotografia Larry Smith
Montaggio Nigel Galt
Musiche Jocelyn Pook
Scenografia Leslie Tomkins
Roy Walker
Massimo Popolizio: Dott. William “Bill” Harford
Gabriella Borri: Alice Harford
Marcello Tusco: Victor Ziegler
Mino Caprio: Nick Nightingale
Massimo Foschi: Sandor Szavost
Cristiana Lionello: Marion Nathanson
Claudia Balboni: Domino
Ilaria Stagni: Sally
Oreste Lionello: Ierofante rosso
Rade Šerbedžija: Sig. Milich
Francesco Vairano: Portiere dell’albergo
Armando Bandini: Uomo giapponese
La colonna sonora:
György Ligeti, Musica ricercata No.II
Dmitrij Šostakovič, Waltz 2 from jazz Suite
Chris Isaak, Baby Did A Bad Bad Thing
Victor Silvester Orchestra, When I Fall In Love
Oscar Peterson Trio, I Got It Bad & That Ain’t Good
Jocelyn Pook, Naval Officer
Jocelyn Pook, The Dream
Jocelyn Pook, Masked Ball
Jocelyn Pook, Migrations
Roy Gerson, If I Had You
Peter Huges Orchestra, Strangers in the Night
Brad Mehldau, Blame It On My Youth
Franz Liszt, Nuages gris
György Ligeti, Musica ricercata No.II – reprise
“Sa qual’è il vero fascino del matrimonio? È che rende l’inganno una necessità per le due parti”.
“C’è una cosa che dobbiamo fare. Scopare”
“Nessun sogno è mai soltanto un sogno”
“Dobbiamo ringraziare il destino. Ringraziarlo, per averci fatto uscire senza alcun danno, da tutte le nostre… “avventure”. Sia da quelle vere, che da quelle solo sognate.”
“Tu la chiami una finta, una sciarada. Ma ti spiace spiegarmi quale diavolo di sciarada finisce con qualcuno che muore davvero?”
Cognome e nome: Lacombe Lucien
Nel giugno del 1944 la Francia è ancora occupata dall’esercito nazista.
Nel sud del paese, ai confini con la Spagna,vive il giovane Lucien che è figlio di un fattore fatto prigioniero dai tedeschi.
La madre del giovane è impegnata nella difficile gestione di una fattoria mentre Lucien lavora come inserviente in una casa di riposo e vive praticamente lontano da casa.
Un giorno recatosi alla fattoria scopre che sua madre ha allacciato una relazione con il padrone della stessa e che la fattoria è piena di sfollati in fuga dalle zone di guerra.
Lucien è un ragazzo ignorante e primitivo che passa il tempo libero sognando di diventare un eroe e che si trastulla con fucile e fionda con i quali uccide poveri animaletti indifesi; non ha alcun ideale, vive in pratica in una sorta di rozza ignoranza che però non è priva di intelligenza.
Sempre alla ricerca di coronare il suo sogno segreto di diventare qualcuno, un eroe, decide di arruolarsi nelle formazioni partigiane ma viene respinto da Peyssac un membro locale delle formazioni combattenti per la libertà.
Pierre Blaise e Aurore Clement
I desideri di Lucien sono destinati ad essere esauditi ma in maniera diametralmente opposta; una sera, rientrato durante il coprifuoco viene fermato e arrestato dalla Gestapo che lo porta in un albergo dove assiste a scene di vita quotidiana degli occupanti, fatta di sfarzo e lusso e di orge.
Tra i partecipanti al festino c’è un gruppo variegato di collaborazionisti, gente che ha trovato il sistema per sfruttare a proprio vantaggio l’occupazione nazista; ci sono l’ex campione di ciclismo Aubert diventato uno straccio umano per colpa dell’alcool, il nobile Jean-Bernard de Voisins che è un altro opportunista che tenta di continuare a fare la bella vita con la sua amante, un simpatizzante nazista, un ex poliziotto e un uomo di colore.
Il gruppo fa bere il giovane Lucien che si ubriaca e fa il nome di Peyssac, il cui destino a quel punto è segnato.
L’uomo accusato di essere un partigiano viene arrestato e sottoposto a tortura mentre Lucien si fa coinvolgere in atti terribili; il giovane partecipa a rastrellamenti durante i quali arriva ad uccidere, sempre sobillato dai compagni che lo spingono sempre più verso l’alcolismo.
Casualmente Lucien conosce Albert Horn, un sarto di origini ebree che è sfuggito ai rastrellamenti grazie ai soldi che paga al poliziotto che fa parte del gruppo collaborazionista.
L’uomo ha una figlia, France e per Lucien arriva l’amore contrastato però da Horn che non ha alcuna simpatia per il giovane.
France dal canto suo prova sentimenti contrastanti per Lucien.
Da un lato è infatuata, dall’altro lo teme sia per i suoi rapporti con i collaborazionisti e di conseguenza con i nazisti sia per il comportamento violento del giovane.
La situazione evolve in peggio e Horn alla fine viene arrestato, non prima però di aver rivendicato con orgoglio la sua nazionalità francese e la sua fede.
Lucien non interviene durante l’arresto, mentre nei giorni successivi i partigiani iniziano una forte controffensiva nel corso della quale vengono uccisi uno alla volta gli sciagurati compagni di avventura di Lucien.
Un gruppo di combattenti entra nell’albergo nel quale sono detenuti alcuni partigiani e Lucien si rende conto che il suo destino è ormai segnato: in un ultimo scatto di orgoglio uccide un tedesco che sta per arrestare sia France che sua nonna e fugge verso la Spagna con loro.
La didascalia finale ci informa sul suo destino….
Diretto da Louis Malle nel 1974, Cognome e nome: Lacombe Lucien è uno splendido spaccato su una delle vicende più tristi della seconda guerra mondiale, un fenomeno che non fu certo solo francese ma esteso a tutti i paesi in guerra occupati dai nazisti, ovvero il collaborazionismo con le forze di occupazione.
Malle, che tre anni prima aveva girato un altro film scandalo, Soffio al cuore (Le Souffle Au Coeur) su un tema scottante come l’incesto, questa volta scava nella memoria storica francese andando a riprendere una delle pagine più oscure dell’occupazione nazista e mostrando al pubblico una storia in cui i protagonisti sono gente comune, anzi, quanto di più comune possa esistere.
A cominciare dal rozzo, ignorante e violento Lucien, che dalla sua ha l’unica scusante di essere un giovane non ancora diciottenne, ma furbo e scaltro. Uno che impara da subito qual’è la via migliore per ottenere quello che vuole e che non esita a uccidere, a tradire non solo per denaro ma per un’oscura voglia di emergere, di non essere una nullità.
Non a caso il suo sogno è impersonificato dall’eroe senza macchia e senza paura.
Eppure finirà per fare scelte completamente diverse, anche se in qualche modo trascinato dagli avvenimenti.
Malle lo rappresenta senza mostrare alcuna simpatia o antipatia per il personaggio.
E’ una vittima delle circostanze oppure è un assassino latente? E’ un violento per natura oppure lo diventa perchè attorno a lui tutto parla il linguaggio della violenza?
Non lo sapremo, perchè anche il finale del film mantiene aperte più soluzioni; di certo Malle con la sua rappresentazione scarna e sintetica del personaggio di Lucien si attirò addosso un nugolo di critiche, la più benevola delle quali parlava di voluta ambiguità.
Il grande regista di Thumeries, lungi dal prendere posizione, si comporta come un entomologo che ha appena trovato un insetto e lo studia da vicino senza giudicare nè la sua bellezza nè le sue capacità: un insetto è un insetto, conta quello che fa, come vive e come vola, non conta certo se esteticamente è repellente oppure no.
Può sembrare un paragone fuori posto eppure credo sia il più adatto alle circostanze.
Malle sa benissimo che ci sono dei nervi scoperti che pure a distanza di 50 anni mantengono aperte ferite mai rimarginate per cui si limita a mostrare una storia particolarmente odiosa, vera e reale senza però fare il giudice.
Lucien e i suoi amici sono farabutti della peggior specie che tradiscono e uccidono non per un ideale ma per bramosia di potere, per il superfluo e anche, cosa più importante, per trovare una rivincita nella vita.
Non a caso sono persone che hanno perso il lavoro, sono insoddisfatti, ubriaconi e violenti.
Dall’altro lato della barricata ci sono i partigiani e l’ebreo Horn, la debole e passiva France, gente che sa bene dov’è il male e da cosa è rappresentato.
Pure, Horn trova un compromesso tra la voglia di vivere e la sua religione, la sua “razza” e la necessità di nascondersi dietro un paravento per evitare di essere deportato. Non a caso accetta di pagare un collaborazionista pur di non essere scoperto. France è succube di Lucien, forse lo ama davvero nonostante il ragazzo sia tutto tranne che un esempio da seguire.
E alla fine si salverà grazie all’unico atto d’orgoglio e di onestà del giovane.
Quindi nel film non ci sono personaggi particolarmente positivi e questo forse ha inficiato il giudizio della critica.
Invece il film è davvero bello, teso e duro, abbellito da una fotografia preziosa opera di Tonino Delli Colli che mostra un contrasto stridente fra il bel paesaggio assolato del sud della Francia opposto alla narrazione di fatti abietti come quelli descritti nel film.
Il cast lavora molto bene, in particolare la bella Aurore Clement che interpreta France Horn; l’attrice di Soissons esordisce così sullo schermo in maniera eccellente, eppure nella sua carriera non otterrà i riconoscimenti che avrebbe meritato. Per avere un’idea dei film nei quali è stata presente, cito L’Agnese va a morire, regia di Giuliano Montaldo oppure Caro Michele, regia di Mario Monicelli (1976),Caro papà, regia di Dino Risi (1979) o Paris, Texas, regia di Wim Wenders (1984) oltre alla partecipazione al capolavoro di Coppola Apocalipse now, dove la sua parte venne completamente tagliata in fase di montaggio.
Bene anche lo sfortunato Pierre Blaise, che purtroppo morirà a soli 23 anni nel 1975, subito dopo aver interpretato Per le antiche scale di Bolognini.
Da segnalare nel cast la presenza della veterana Ave Ninchi nel ruolo della proprietaria dell’hotel in cui si riunisce la Gestapo.
Cognome e nome: Lacombe Lucien è un gran film, che avrebbe meritato ben più della sola nomination all’Oscar del 1974; purtroppo ( o per fortuna) quell’anno in concorso c’era lo splendido Effetto notte di Truffaut che vinse se vogliamo con merito nella categoria Miglior film straniero.
Un film da riscoprire, per meditare e passare 2 ore davanti all’opera di un grande maestro della cinematografia mondiale.
Cognome e nome: Lacombe Lucien
Un film di Louis Malle. Con Ave Ninchi, Aurore Clément, Pierre Blaise, Holger Lawenadler, Thérèse Giehse,Donato Castellaneta Titolo originale Lacombe Lucien. Drammatico, durata 135 min. – Francia 1974.
Pierre Blaise: Lucien Lacombe
Aurore Clément: France Horn
Holger Löwenadler: Albert Horn
Therese Giehse: Bella Horn, nonna di France
Stéphane Bouy: Jean-Bernard de Voisin
Loumi Iacobesco: Betty Beaulieu
René Bouloc: Stéphane Faure
Gilberte Rivet: madre di Lucien
Pierre Saintons: Hippolyte, il collaborazionista di colore
Ave Ninchi: Madame Georges, proprietaria dell’albergo
Regia Louis Malle
Soggetto Louis Malle e Patrick Modiano
Fotografia Tonino Delli Colli
Montaggio Suzanne Baron
Musiche Django Reinhardt
Scenografia Ghislain Uhry
Foto di scena del film
Luna di fiele
Su una nave da crociera diretta in Turchia è imbarcata una coppia di sposi che sta festeggiando il settimo anno di matrimonio.
E’ un anniversario che è temuto da tutte le coppie, un giro di boa dei matrimoni che spesso si sfaldano prima del fatidico settimo anno e Nigel e Fiona sembrano essere i coniugi adatti alla raffigurazione visiva di questa crisi.
Sono paludati, ingessati; si vogliono bene ma il loro sembra un matrimonio senza sbocchi, soporifero e da vestaglia e ciabatte davanti alla tv.
Sulla stessa nave è imbarcata un’altra coppia, specularmente e totalmente opposta a quella formata da Fiona e Nigel; si tratta di quella composta da Oscar e Mimi.

I coniugi Fiona e Nigel, Kristin Scott Thomas e Hugh Grant
Lui, come apprendiamo in seguito, è uno scrittore di bassa caratura però ricco quanto basta per non aver problemi economici di sorta; è seduto su una sedia a rotelle mentre sua moglie Mimi è una donna dal fascino sensuale ma sinistro.
Siamo a fine d’anno, per cui sulla nave c’è l’atmosfera tipica della festa che precede il capodanno.
Oscar inizia a puntare Nigel, che dapprima sta sulle sue, poi si lascia andare ad un rapporto di confidenza con lo scrittore; ad attrarlo non è tanto l’uomo quanto piuttosto Mimi che appare lunare e attraente come un mulinello nell’acqua.
Così Oscar inizia a raccontare la storia degli ultimi anni a Nigel, che dapprima ascolta distratto, poi con evidente voyeurismo acustico quelle che sono le vicissitudini dello scrittore che parla di come ha conosciuto la bellissima e inquietante moglie.
Ricco e sfaccendato, Oscar incontra Mimi su un autobus.
… ma anche perversa
La donna è priva di biglietto, ma lui riesce a passargliene uno e da quel momento inizia tra loro una storia d’amore assolutamente particolare.
Travolti dai sensi, Oscar e Mimi fanno l’amore di continuo e ovunque, sperimentando anche pratiche sessuali estreme.
Pur di seguire quello che è il suo amore, totalizzante ed esclusivo, Mimi rinuncia al suo sogno di diventare una ballerina e lascia anche il suo lavoro.
Ma anche le storie d’amore più intense possono finire, così un giorno Oscar decide di chiudere con Mimi. La donna non ci sta, perchè è innamorata così arriva ad umiliarsi in tutti i modi per quello che considera il suo uomo.
Ma Oscar è stufo così un giorno pur di togliersela di torno la invita ad un viaggio in Martinica; prima di partire Oscar scende dall’aereo lasciando Mimi diretta verso la meta esotica.
Per un paio d’anni Oscar non fa altro che passare da un letto all’altro, concedendosi una serie incredibile di avventure sessuali e riprendendo la vita da bohemien che conduceva prima di incontrare Mimi.
Il destino però è dietro l’angolo e si materializza in un incidente durante il quale Oscar riporta la frattura di una gamba.
In ospedale arriva Mimi, che si vendica in maniera crudele: manovrando sull’apparecchio che mantiene in trazione la gamba di Oscar e rovesciandolo provoca la paralisi degli arti inferiori dell’uomo.
Che da quel momento è costretto ad accettare le cure di Mimi, diventando (forse consapevolmente) la vittima di quella donna diventata astiosa e vendicativa.
In una specie di rapporto da Sindrome di Stoccolma, Oscar e Mimi si legano in maniera perversa.
La donna lo tradisce sotto i suoi occhi, lo maltratta e lo umilia in tutti i modi, lasciandolo per esempio nell’acqua gelata oppure negandogli un colloquio importante con un editore che vorrebbe pubblicare il libro di Oscar.
Oscar descrive questa situazione ambigua del rapporto esistente tra lui e Mimi ad un Nigel falsamente interessato alla vicenda; in realtà l’uomo è attratto da Mimi e Oscar, che ha evidentemente un piano nella testa, lo spinge ad avvicinarsi a sua moglie.
Mimi non ha alcun interesse per l’anonimo Nigel, così dirige le sue attenzioni sulla moglie di quest’ultimo, Fiona, che finora è rimasta abbastanza defilata; la donna infatti soffre di mal di mare è passa diverso tempo in cabina.
Durante un ballo scatenato che introduce la fine dell’anno Mimi invita a ballare Fiona e dopo un languido tete a tete sulle note di Slave to love di Brian Ferry bacia appassionatamente la donna sulla bocca.
Così Mimi e Fiona vanno a consumare la loro improvvisa passione in cabina, mentre Oscar resta nella sala in festa.
La sera scoppia la tragedia.
Nigel ritrova finalmente la moglie, che è addormentata nuda accanto a Mimi; sul posto c’è anche Oscar che improvvisamente estrae la pistola che la moglie gli aveva regalato, la impugna e spara alcuni colpi sul corpo nudo di Mimi, poi rivolge la pistola su se stesso e fa fuoco.
Le ultime immagini sono riservate a Nigel e Fiona, che forse d’ora in poi vivranno un matrimonio più “imprevedibile”.
O forse no….
Luna di fiele è un film assolutamente particolare diretto da uno dei geniacci del cinema, quel Roman Polanski che ci ha sempre abituato ad uno standard qualitativo altissimo.
Anche in questo film la mano del grande regista si vede e si sente in quasi tutti i fotogrammi della pellicola, eppure Luna di fiele è un film non completamente riuscito.
Dalla sua ha una ambientazione claustrofobica realizzata con la solita bravura, una caratterizzazione dei personaggi di Mimi e Oscar molto ben curata, una tensione palpabile mentre i limiti sono essenzialmente da ricercare nella scarsissima descrizione della coppia Nigel/Fiona, che avrebbe meritato più spazio e che avrebbe permesso al regista si scandagliare anche il matrimonio borghese e senza sussulti della coppia.
Va detto però, a parziale scusante di Polanski, che il film ha l’obbligo di muoversi entro i limiti del racconto tratto dal romanzo Bitter moon di Pascal Bruckner (Luna di fiele nella versione italiana cinematografica, mentre in America il film è uscito con il titolo originale del romanzo)
Polanski indaga sul rapporto di coppia, usando l’imparzialità e l’assoluta mancanza di critica o approvazione latente o palese per descrivere il tormentato, ambiguo rapporto tra Mimi e Oscar.
La loro storia nasce e si sviluppa come una storia qualsiasi per poi incamminarsi nei meandri oscuri di un rapporto costruito sull’annientamento della personalità, attraverso l’esplorazione degli abissi dell’eros e dell’anormalità sessuale, ammesso che si possa usare un’eccezione del termine che descriva cosa e lecito o cosa non lo è nella sfera intima della sessualità.
“Ogni rapporto tra uomo e donna, anche se armonioso, ha in se il seme della farsa o della tragedia“, dice Oscar nel suo colloquio ( anche soliloquio, se vogliamo) rimarcando le caratteristiche che ben presto connoteranno in maniera così forte la simbiosi di coppia tra lui e Mimi, oppure dice anche (esplicando in qualche modo la vera natura del rapporto tra lui e Mimi, “Avevo sempre sospettato che fosse estremamente piacevole essere umiliati da una bella donna, ma non potevo immaginare fino a che punto un uomo ne potesse essere coinvolto…”
Un simbiosi cementata dalla sessualità sfrenata, ago della bilancia del rapporto tra i due, con Mimi che si lascia andare a un rapporto di coppia totale e disinibito, sottile metafora dell’esplicazione dell’individuo attraverso quello che più di recondito esiste nella mente.
Illuminante è la lunga descrizione che Oscar fa di una delle esperienze vissute dalla coppia:
“Le stagioni venivano e passavano.. il volto di Mimi per me nascondeva sempre mille misteri, il suo corpo mille dolci promesse.. ma nel mio inconscio si affacciava di tanto in tanto la paura inconfessata che la nostra relazione fosse ormai arrivata al culmine e che da quel momento in poi potesse cominciare il declino. Poi accadde qualcosa una cosa che avrebbe messo tutto su un piano completamente diverso. Eravamo a Kitzbuhe in vacanza a sciare, avevo affittato uno scialè, era una notte particolare in casa stavamo caldi e comodi, grandi e pesanti fiocchi di neve volteggiavano dolcemente nell’oscurità, dietro ai vetri appannati, nessuna luce.. solo quella del televisore. Mimi stesa sul pavimento con solo una t-shirt intenta a guardare un vecchio serial americano doppiato in tedesco e io sulla poltrona che la fissavo perso in una specie di intontito stupore. All’improvviso lei si alza si avvicina al televisore, allarga le gambe e piscia sullo schermo come se volesse cancellarlo.. è stato come se il tempo si fosse fermato. Sono rotolato giù dalla poltrona e ho strisciato verso di lei fino ad infilarmi tra le sue gambe e mi sono rigirato, sono stato subito investito da quella calda dolcissima dorata cascata che mi inondava le guance, che mi riempiva le narici e mi pungeva gli occhi, finché qualcosa mi è scoppiato nel cervello con l’intensità di una scarica di multi mega volt… un lampo accecante mi ha oscurato completamente la vista ma ho avuto il più sublime, incredibile orgasmo della mia vita! È stato come se una lama infuocata mi trapassasse più e più volte, era il mio Nilo, il mio Gange, il mio Giordano, la mia fonte di giovinezza, il mio secondo battesimo.”
Leggendo le varie recensioni al film mi sono imbattuto in alcune in cui si puntava l’indice su un presunto discorso nichilista sul matrimonio fatto dal regista; a mio parere è una lettura errata, in quanto Polanski parla di due coppie e non generalizza o estende quelle che sono due situazioni specifiche ad un discorso più ampio sulla crisi della coppia.
Mimi e Oscar sono una coppia assolutamente particolare, Nigel e Fiona sono una coppia assolutamente normale, una coppia borghese senza più stimoli, probabilmente, ma che dall’incontro con quella che possiamo definire perversione di coppia costituita da Mimi e Oscar uscirà probabilmente rafforzata e con nuova linfa.
Polanski chiama ad interpretare il difficilissimo e scabroso ruolo di Mimi la bella e misteriosa oltre che sensuale Emmanuelle Seigner, già diretta in Frantic; l’attrice francese con la sua carica enorme di sensualità ripaga tutti con un’interpretazione magistrale.
Forse non è una grande attrice, come sottolineano alcuni detrattori, ma ha una carica erotica, un modo di guardare che colpiscono senza pietà, una sorta di sessualità quasi animale che traspira da ogni parte del suo corpo.

Il resto del cast lavora con molta efficienza; bene Coyote, benissimo Kristin Scott Thomas, indecifrabile Hugh Grant che ha una scusante.
Il suo è il ruolo di un voyeur uditivo, penalizzato anche dalla mancanza di una personalità definita e di un ruolo attivo nel film.
Menzione particolare per le musiche di Vangelis, puntuali e claustrofobiche.
Un film da vedere assolutamente.

Il regista Roman Polanski sul set del film
Luna di fiele
Un film di Roman Polanski. Con Kristin Scott Thomas, Peter Coyote, Hugh Grant, Emmanuelle Seigner, Victor Banerjee Titolo originale Bitter Moon. Drammatico, durata 142 min. – Francia, Gran Bretagna 1992.
Hugh Grant: Nigel
Kristin Scott Thomas: Fiona
Emmanuelle Seigner: Mimi
Peter Coyote: Oscar
Victor Banerjee: Mr. Singh
Sophie Patel: Amrita Singhr
Regia Roman Polanski
Soggetto Pascal Bruckner (romanzo)
Sceneggiatura Roman Polanski, Gérard Brach, John Brownjohn
Produttore Roman Polanski, Alain Sarde (coproduttore)
Produttore esecutivo Robert Benmussa
Casa di produzione R.P. Productions, Timothy Burrill Productions, con la partecipazione di Les Films Alain Sarde e Canal+
Fotografia Tonino Delli Colli
Montaggio Hervé de Luze
Musiche Vangelis
Scenografia Willy Holt, Gérard Viard
Costumi Jackie Budin
Ogni rapporto tra uomo e donna, anche se armonioso, ha in se il seme della farsa o della tragedia. (Oscar)
Era inutile… Non riuscivo a scrivere, non riuscivo a dormire, non riuscivo a togliermela dalla testa! Lei era là da qualche parte.. la mia strega con le scarpe da ginnastica bianche.. Ma dove? (Oscar)
Parigi… la città dei miei sogni! Hemingway, Miller, Scott Fitzgerald… ero deciso a seguire le loro orme.. forse anche troppo deciso per le mie capacità, perché probabilmente tutto questo ha ucciso in me ogni traccia di originalità, se mai l’ho avuta. (Oscar)
Io non so nemmeno chi sei Nigel, ma non so perché ho la sensazione che tu sia l’ascoltatore che cerco da tanto tempo, spero che troverai interessante la mia storia. Capisco che è difficile essere partecipi a qualcosa che non ti riguarda… o forse ti riguarda già. (Oscar)
Sì… l’eternità per me è cominciata una giornata d’autunno a Parigi, sul vecchio autobus 96 che fa il percorso da Montparnasse a Port De La Gare. (Oscar)
America oggi
America oggi (1993) di Robert Altman è uno spaccato sugli Usa che assomiglia pericolosamente e in maniera sinistra alla società moderna di uno qualsiasi dei paesi industrializzati, non necessariamente occidentali.
Un film cinico e crudele e allo stesso tempo asettico come una sala operatoria, cattivo al punto giusto e didascalico, con storie intrecciate legate fra loro da sottilissimi fili a con protagonista un’umanità disorientata e a tratti amorale, maleducata e sfrontata, rissosa e priva di orientamento.
Altman utilizza 9 racconti e 1 poesia di Raymond Carver, lo scrittore di Clatskanie morto 23 anni addietro all’età di 50 anni e li trasforma in potenti immagini cinematografiche usando un linguaggio crudo ed essenziale, un pò come sono le vite dei vari protagonisti del film.
L’America pre 11 settembre appare desolante, chiusa in egoismi personali, in cui i rapporti umani appaiono mediati solo dall’interesse o dall’ego dei vari soggetti, pronti ad aggredire e a plagiare le vite altrui.
Gli altri però fanno lo stesso, così alla fine guardiamo amareggiati un gatto che si morde la coda, riflettendo però su quanto siamo simili noi a quella gente che ci appariva distante anni luce.
Si, perchè nel frattempo il film di Altman si è attualizzato, così che un italiano piuttosto che un inglese o un francese possono riconoscere buona parte dei propri difetti in una pellicola che non risparmia niente.
Il senso desolante di deja vu nella vita quotidiana si fa così pressante e per fortuna il grande regista americano si limita ad una fredda esposizione di storie e situazioni, senza accennare ad alcun biasimo morale o senza prendere posizione.
Il film dura 188 minuti, un’enormità.
Le storie che seguiamo sullo schermo, intimamente collegate fra loro si incrociano, si dividono.
I protagonisti litigano, fanno cose tremende sotto i nostri occhi; lo spettatore finisce per chiedersi se dentro di se non aleggi malignamente lo spettro evocato sullo schermo, se quel personaggio in fondo in qualche modo non gli somigli.
Dal volo degli elicotteri iniziale, quasi un Apocalipse now in versione metropolitana al terremoto finale, non potentissimo ma che sembra presagire lo spettro del temutissimo Big one, il terremoto che raderebbe al suolo buona parte dei totem della civiltà americana, è un susseguirsi di storie tragiche nella loro banalità.
Così come in fondo è banale l’esistenza dell’uomo qualunque descritta nel film, fatta di birra e sesso ma anche di malignità, rivalità e gelosie.
La donna sposata con due figli, che lavora come voce erotica e che cambia il pannolino alla figlia mentre sussurra parole a luce rossa al telefono, sotto lo sguardo quasi assente di un marito frustrato è una delle immagini più spietate del film. E’ un “lavoro” semplice, il suo; in fondo parlare di sesso orale mentre tuo figlio segue la tv o tua figlia ti sputa in faccia l’omogeinizzato è sempre meglio che alzarsi presto per andare in fabbrica.
Cosa c’è di meglio che ripetere oscenità stando semplicemente seduta a casa o impegnata nelle faccende domestiche?
E’ questa l’America oggi di Altman.
E’ quella dei pescatori in libera uscita che mentre pescano sulle rive di un torrente rinvengono un corpo nudo di ragazza e decidono di non privarsi del divertimento, ignorandolo e continuando a pescare; “Perchè pisci nell’acqua?“, chiede uno dei pescatori, “Mi piace il rumore che fà” è la risposta di colui che scopre il cadavere della ragazza che giace poco sotto il pelo dell’acqua.
The show must go on, il divertimento deve andare avanti perchè è il personale che conta, non l’altro.
Così i pescatori sono l’emblema di un americano medio ormai narcotizzato a tal punto da considerare la morte degli altri un intralcio, una limitazione al proprio piacere.
C’è l’americano crudele e menefreghista, rappresentato dal telegiornalista che in ospedale sta seguendo un avvenimento drammatico, la morte del figlio mentre suo padre con il quale non è più in contatto da tanti anni si disinteressa della sorte del nipote, recandosi a far visita ad un giovane nella stanza accanto, con il quale non ha nessun legame di sangue e che non ha mai visto prima: è la disgregazione della famiglia?
In un certo senso si, perchè la famiglia tradizionale ormai è un dinosauro estinto da tempo, consumato dall’egoismo personale e dalla mancanza di valori, che ormai resiste solo nel ricordo come qualcosa che c’era e non c’è più, che non richiede nemmeno il rimpianto.
America oggi è la coppia mal assortita con lui ubriacone e alcolizzato e lei cameriera, che si riavvicinano dopo un incidente durante il quale la donna travolge e uccide il figlio dei vicini.
Tutte le storie sono legate fra loro, come dicevo all’inizio ma in realtà possono essere considerate come vite parallele di universi paralleli, distanti e destinati a non incontrasi se non per puro caso, a incrociare le vite non volutamente ma per quella causalità che è poi una delle caratteristiche specifiche della vita.
Questi i tanti pregi del film.
Che venne giustamente omaggiato alla Mostra del cinema di Venezia con il Leone d’oro.
Tuttavia un difetto di base c’è ed è grande come una casa.
Tre ore e passa di film sono davvero tante per un film che in pratica dedica oltre 20 minuti in media ad ogni singolo episodio pur inquadrabile in un quadro di fondo omogeneo; la tendenza di Altman ad essere principalmente didascalico e a basare gran parte del film sui dialoghi può ingenerare insofferenza nello spettatore.
Generalmente film così lunghi appartengono alla tradizione dei film d’avventura o alle epopee alla Dottor Zivago o ad affreschi (grandiosi) come i film di Leone.
Altman osa l’inosabile arrivando a mostrare 180 minuti di vita vera in cui però ad un certo punto ci si smarrisce proprio per l’estenuante concatenarsi delle storie e delle vicende dei vari protagonisti; un difetto non da poco.
Quando Altman gira America oggi è reduce dal gran successo di I protagonisti, girato l’anno precedente che ottenne la Palma d’oro a Cannes; è quindi un periodo fecondo, quello del gran regista americano, reduce da anni di lavoro quasi oscuro segnato da produzioni low budget e da sperimentazioni.
Per questo film ingaggia un gruppo di attori emergenti o già affermati, inserendo anche la star Jack Lemmon; nel cast troviamo Andie MacDowell e Julianne Moore, Tim Robbins e Madeleine Stowe, Jennifer Jason Leight, Tom Waits… insomma un cast che alla fine risulta omogeneo nonostante le diverse scuole di recitazione dalla quale provengono gli attori, che si muovono all’unisono sullo sfondo asettico della città degli angeli.
A fare da collante al film, una colonna sonora classica fino al midollo.
Si spazia (in senso letterale strettissimo,perchè la mente vola sulle note) da Bach a Dvorak con il suo cello, da Igor Stravinsky a Mark Isham; una musica che ci trasmette il senso apocalittico del film.
L’apocalisse di Altman, la rivelazione in senso letterale non è quella biblica, ma è quella metropolitana, la disperata solitudine dei gesti e delle parole, di tutti i protagonisti messi di fronte alla loro realtà quotidiana che rappresenta il passato, il presente e probabilmente anche il futuro.
Noi sappiamo che al momento non è ancora accaduto quanto lasciato presagire da Altman; ma l’America oggi del 1993 non è l’America post 11 settembre, quella per intenderci che ha scoperto di essere vulnerabile e non più invincibile, il grande mito dell’epopea storica americana.
E’ una nazione piena di contraddizioni che si sono acuite e che Altman in qualche modo aveva presagito.
Qesto forse è il gran merito di America oggi, l’aver posto delle domande senza retorica, l’aver mostrato un mondo in crisi già vent’anni addietro.
Una crisi che è allo stesso tempo strutturale,individuale, sociale, collettiva, di sistema e di ideologia.
Tanta carne al fuoco cucinata benissimo da uno dei grandi maestri della cinematografia.
America oggi
Un film di Robert Altman. Con Anne Archer, Jack Lemmon, Madeleine Stowe, Lily Tomlin, Tim Robbins,Matthew Modine, Tom Waits, Buck Henry, Andie MacDowell, Fred Ward, Peter Gallagher, Bruce Davison, Julianne Moore, Chris Penn, Jennifer Jason Leigh, Robert Downey Jr., Frances McDormand, Lori Singer, Lyle Lovett, Huey Lewis
Titolo originale Short Cuts. Drammatico, durata 188 min. – USA 1993.
Andie MacDowell: Ann Finnigan
Bruce Davison: Howard Finnigan
Jack Lemmon: Paul Finnigan
Julianne Moore: Marian Wyman
Matthew Modine: Dr. Ralph Wyman
Tim Robbins: Gene Shepard
Madeleine Stowe: Sherri Shepard
Anne Archer: Claire Kane
Fred Ward: Stuart Kane
Jennifer Jason Leigh: Lois Kaiser
Chris Penn: Jerry Kaiser
Lili Taylor: Honey Bush
Robert Downey Jr.: Bill Bush
Tom Waits: Earl Piggot
Lily Tomlin: Doreen Piggot
Frances McDormand: Betty Weathers
Peter Gallagher: Stormy Weathers
Annie Ross: Tess Trainer
Lori Singer: Zoe Trainer
Lyle Lovett: Andy Bitkower
Buck Henry: Gordon Johnson
Huey Lewis: Vern Miller
Regia Robert Altman
Sceneggiatura Robert Altman, Frank Barhydt
Fotografia Walt Lloyd
Montaggio Suzy Elmiger Geraldine Peroni
Musiche Johann Sebastian Bach Antonín Dvorák Gavin Friday Victor Herbert Mark Isham Doc Pomus Igor Stravinsky


Capolavoro di uno dei più grandi registi americani contemporanei: con questo film (cui devono molto Magnolia di Anderson e Crash di Paul Haggis), Altman conferma la sua abilità nel raccontare storie; la sceneggiatura è quasi perfetta e la durata del film (pur non indifferente) non pesa sullo spettatore grazie alle ottime performance di un grande gruppo di attori (tra i migliori del cinema americano) tra i quali spiccano Jack Lemmon e Julianne Moore.
Un capolavoro. Il graffio beffardo e amaro del grande Altman colpisce ancora con un affresco di storie meschine e disperate di una grande metropoli sull’orlo del baratro: il terremoto fisico, pronto a sancire apocalitticamente la fine di un mondo che ha perso l’orizzonte dell’etica e dell’umanità. Straordinaria la capacità di raccontare “banalmente” le micro-storie “banali” dei diversi personaggi “banali” che si intrecciano più o meno casualmente, trasformando tutto in una catastrofe antropologica. Epocale.
Tratto da un libro di racconti di Carver, un gran film corale griffato Altman che si conferma il regista più capace nel girare pellicole di questo tipo. Tante storie che si intrecciano molto bene tra loro con denominatore comune lo sguardo impietoso e pessimista nei confronti del popolo americano. La durata fiume (tre ore piene) non impedisce un ottimo controllo del materiale narrativo e dell’incastro tra i vari pezzi. Inoltre tutti gli attori del ricchissimo cast sono diretti, al solito, molto bene e fanno la loro parte.
Alcuni giorni nelle vite di abitanti di LA, fatterelli, amori, liti, drammi. Ispirato ai racconti di Raymond Carver, il film è il capostipite di un filone i cui epigoni non sono riusciti ad avvicinarsi al modello, forse proprio per la mancanza di una solida base di scrittura. La cruda prosa minimal di Carver finisce sullo schermo disegnando storie comuni che ci costringono a guardare, o almeno a sbirciare anche dentro di noi. Straziante l’episodio (quasi letteralmente preso dal racconto) della torta di compleanno. Non per tutti, ma bellissimo.
America oggi sta agli anni 90 come Nashville stava agli anni 70. Assoluto capolavoro Altmaniano, forse il suo film testamento, una summa di tutto il suo cinema. Gli elicotteri all’inizio che sovrastano Los Angeles fanno venire alla mente il Coppoliano Apocalypse now, Jennifer Jason Leigh che fa sesso telefonico mentre è affacendata in lavori domestici, un cadavere di donna che galleggia nelle fogne, Chris Penn che dà improvvisamente di matto ed esplode in una violenza feroce e inaspettata con l’arrivo del terremoto… Capolavoro.
Episodi drammatici come la perdita di un figlio, ordinari come mariti e mogli con amanti vari, surreali come una madre che alleva i propri figli mentre lavora al telefono per una hot-line: è questo il quadro bizzarro che Altman riesce a cucire insieme realizzando un film di oltre 3 ore che non pesano assolutamente. Lo spettatore si diverte a riconoscere dai piccoli curatissimi particolari le peculiarità di ogni personaggio. Un cast eccezionale mantiene alto il livello recitativo.
Ennesimo grande film per l’indiscusso Maestro del cinema corale USA. Uno sguardo approfondito, veritiero ma distaccato nelle vite di una serie di personaggi che vivono nella realtà e che vivono la vita come tutti noi, ognuno con i propri problemi, ognuno con i propri ostacoli da superare. Altman dirige l’intricata matassa splendidamente, con lo sguardo analitico e lucido di chi vuole lasciare allo spettatore la possibilità di giudizio. Ma i toni disperati e impietosi non lasciano scampo… anche ai non americani, ovvio. Egregiamente interpretato.
Uno splendido manifesto core. Le storie di nove o più famiglie si intrecciano, si collegano tra loro in un modo o nell’altro, anche solo per uno sguardo o una situazione. Uno scontro continuo che scivola in un vortice di tensione, culminante con un avvenimento/metafora finale. Ed è in questo modo che possiamo seguire le vite e le vicissitudini di alcuni personaggi dell’America anni ’90 allo sbando. Altman si “limita”, in maniera eccellente, a raccontare gli avvenimenti con grande lucidità e partecipazione, lasciando a noi la libertà di giudicare.
America oggi è un’appropriata traduzione italiana di ciò che il film vuole mostrare: una nazione quanto più malata e disastrata anche nei ceti medi (-alti). Le tre ore di durata certo non facilitano la gestione del ritmo ed infatti si notano alcuni cali sopratutto nella parte centrale, che pur non essendo gravi si fanno sentire. Comunque bilanciato è il cast, composto da molti volti noti. Ottima la regia di Altman.
Interessante sguardo realista dell’America (di ormai 20 anni fa), il film è l’intreccio di vite di molti personaggi a Los Angeles; più che altro si sofferma sui problemi delle giovani coppie, i tradimenti, le insicurezze e i rapporti genitore/figlio. Un film vero e drammatico che raccoglie qualche giorno di quotidiana vita intrecciata in un meccanismo perfetto di incontri/scontri.
Bagdad Cafè
Una coppia di coniugi tedeschi si ferma in una zona solitaria e inizia una furiosa lite.
La donna, dalla massiccia corporatura, raccoglie una valigia e messasi sulla testa il caratteristico copricapo bavarese si incammina sulla strada solitaria.
La scena si sposta all’interno del Bagdad Cafè, una struttura fatiscente e sporca che funziona da pompa di benzina, bar e motel ed è diretta da Brenda, una energica donna di colore con un marito fannullone e stranito e con tre figli oltre ad un nipotino in fasce.
Brenda litiga furiosamente con il marito che decide di andarsene, poi si lascia andare ad una crisi di sconforto; dei tre figli infatti nessuno sembra voler collaborare con la donna e l’unico dipendente della struttura, il barista, sembra essersi adeguato al clima di lassismo che impera nel Bagdad Cafè.
Mentre Brenda è seduta fuori dal bar, sconsolata per le responsabilità che deve affrontare, vede spuntare dalla statale che attraversa il deserto del Mojave la sagoma ingombrante della turista tedesca, ansimante e sudata sotto un sole implacabile.

L’arrivo della sudatissima Jasmin al Bagdad Cafe
La donna, Jasmin, chiede una stanza e la perplessa Brenda le affitta una stamberga sporca e malsana.
Da quel momento le cose iniziano lentamente a cambiare; Jasmin, silenziosa ed efficace, approfitta dell’assenza di Brenda andata in città per rifornimenti per ripulire la sua stanza e successivamente l’ufficio di Brenda e poco alla volta il bar e gli altri locali dell’impianto.
I pochi avventori abituali del motel, fra i quali c’è l’ex pittore di fondali di Hollywood Rudi Cox e una ragazza silenziosa che fa tatuaggi si abituano a quella presenza silenziosa ed efficiente; Cox, incuriosito dalla donna, cerca subito la sua amicizia che la donna gli concede.
Al ritorno Brenda, sorpresa, trova i cambiamenti apportati da Jasmin ma non ne è affatto contenta e si scontra con la donna, arrivando a chiamare lo sceriffo per capire se la donna ha qualcosa da nascondere.
L’inizio del rapporto tra le due donne è quindi tempestoso, ma è destinato a modificarsi con il tempo.
Jasmin infatti ha un carattere solare, anche se estremamente riservato e si fa amare per la sua capacità di saper cogliere in ognuno dei presenti al Bagdad Cafè il meglio delle loro personalità.
Incoraggia Salomon (il figlio di Brenda),che è un bravo musicista a suonare la musica classica, che ama; riesce a dialogare con la giovane Phyllis che vive immersa nella musica diffusa dal suo walkman, diventa modella di Cox che la ritrae in numerosi dipinti.
Poco alla volta anche Brende si scioglie.
Accade infatti che Jasmin, che è scappata portando via per errore la valigia del marito, abbia trovato all’interno di essa una scatola che insegna i rudimenti della magia; la donna con molta applicazione diventa una brava illusionista e propone i suoi spettacolini ai rari avventori del locale, che da quel momento iniziano ad aumentare, attratti dalla novità e sopratutto dalla pulizia e dall’ordine che adesso regnano al Bagdad Cafè.

Il titolo originale del film, Out of Rosenheim
Poco alla volta il successo arride al locale, che diventa la meta preferita di giovani e camionisti, che si passano parola con i loro barracchini.
Jasmin diventa così un’amica, una confidente e un’attrazione del locale, un punto fermo assolutamente imprescindibile per la piccola comunità che gravita attorno al locale.
Purtroppo è in arrivo un colpo di scena.

Jack Palance, bravissimo, è Rudi Cox
Lo sceriffo comunica a Jasmin che il suo permesso di soggiorno è scaduto e che quindi la donna deve ritornare in patria, nella sua città natale di Rosenheim.
La partenza di Jasmin che lascia a malincuore il suo gruppo di amici getta nella costernazione la comunità che poco alla volta si lascia andare, ritornando alla piatta vita precedente.
Ma un giorno, mentre Brenda è fuori in cortile immersa nei suoi pensieri, vede in lontananza l’inconfondibile sagoma di Jasmin, questa volta vestita di tutto punto, fresca e sorridente essendo arrivata in taxi.
Le due donne, ormai amiche, si abbracciano.
E’ l’inizio di una nuova vita, per il Bagdad cafè;Brenda partecipa anch’essa agli spettacolini organizzati da Jasmin e si riprende in casa il marito, tornato con la coda tra le gambe.
Il locale ha sempre più successo e alla fine Jasmin decide di restare per sempre in quel posto dove è amata e rispettata e accetta anche la corte di Cox, che la chiede in sposa.

Marianne Sägebrecht è Jasmin Muenchgstettner
Il film termina con la battuta di Jasmin, che di fronte alla richiesta di Cox, risponde sorridendo maliziosamente “devo chiederlo a Brenda”
Bagdad cafè è una commedia dei buoni sentimenti, strutturata quasi come una favola con il gran pregio di non risultare mai melensa o sciropposa.
Giocata sul forte contrasto tra i due personaggi principali, l’enigmatica e seria signora Jasmin, teutonica ed efficace in tutte le sue azioni e l’afro americana Brenda, anch’essa efficiente ma costretta dalle circostanze a dover affrontare un nugolo di problemi completamente da sola, la pellicola vive di dialoghi stringati, di caratterizzazioni di personaggi, di descrizioni ambientali in senso di atmosfera.
Il piccolo cosmo che ruota attorno al Bagdad cafè trova nella signora Jasmin un punto di riferimento imprescindibile; dai figli di Brenda, al barista passando per il buon Cox, tutti sono affascinati, ammaliati da quel personaggio silenzioso che irrompe con delicatezza nelle loro vite, grazie all’enorme pregio di saper ascoltare e confortare senza usare parole vane.
Il personaggio di Jasmin così finisce per diventare assolutamente indispensabile a tutti; i clienti, il giovane Eric che si è accampato accanto al Bagdad Cafè e che passa il suo tempo lanciando il boomerang e riprendendolo hanno bisogno di lei, che ha sempre una parola di incoraggiamento per tutti.
E che porta il Cafè dall’essere una topaia all’essere il punto di ritrovo del circondario, desolato e selvaggio come solo i deserti sanno essere.
Percorso dalla straordinaria colonna sonora di Jevetta Steele, quella Calling you che in seguito sarà ripresa da artisti del calibro di Tracy Chapman, Barbra Streisand, George Michael, Jeff Buckley, Céline Dion, il film si rivela una commedia intensa e a tratti toccante, che mostra come il dialogo tra genti e culture diverse possa essere basato sul rispetto reciproco, sulla comprensione delle diverse abitudini e stili di vita.
Straordinarie le due attrici protagoniste.
Marianne Sägebrecht che interpreta la teutonica Jasmin da corpo ad un personaggio ricchissimo di sfaccettature quanto enigmatico e solare ma allo stesso tempo comunicativo, grazie sopratutto alla straordinaria mimica facciale dell’attrice.
Stesso discorso per Carol Christine Hilaria Pounder, conosciuta come CCH Pounder, di origini guyanesi, che interpreta Brenda caratterizzandola al meglio con un’interpretazione da Oscar; il suo personaggio, umanamente simpatico aldilà di certi risvolti burberi è una delle cose migliori del film.
Ottimo anche Jack Palance, a suo agio nei panni insoliti di un gentiluomo americano di campagna che si innamora della dolce Jasmin.
Sia la Sägebrecht che la Hilaria Pounder sono agli antipodi dal prototipo della diva vamp americana; sono le donne di tutti i giorni, quelle che combattono la dura realtà del quotidiano; hanno corpi da massaia, come vedremo nel caso di Jasmin che poserà a seno nudo per Cox, fanno i gesti della casalinga sempre monotonamente uguali. Ma lo fanno con quella forza che le rende straordinarie.
Bagdad Cafè è un gran bel film, che insegna il rispetto per la diversità,la tolleranza, la multi razzialità.
Un pregio, insomma.

L’abbraccio tra le due amiche ricongiunte
Ed è e diretto da un bravo regista come Percy Adlon, capace di essere allo stesso tempo regista e sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia; la sua regia è agile e asciutta, capace di cogliere aspetti generalmente tralasciati come la caratterizzazione profonda dei personaggi.
Da vedere assolutamente per passare due ore in compagnia di un gran cinema.
Bagdad Café,un film di Percy Adlon. Con Jack Palance, Marianne Sägebrecht, CCH Pounder,James Gammon Titolo originale Out of Rosenheim. Commedia, durata 112 min. – Germania 1987

Lo spettacolo di magia organizzato da Brenda e Jasmin

Le due amiche litigano scherzosamente

Uno dei tanti quadri realizzati da Rudi Cox

Jasmin, una buffa ma irresistibile signora tedesca
Marianne Sägebrecht: Jasmin Muenchgstettner
CCH Pounder: Brenda
Jack Palance: Rudi Cox
Christine Kaufmann: Debby
Monica Calhoun: Phyllis
Darron Flagg: Salomo
George Aguilar: Cahuenga
G.Smokey Campbell: Sal
Hans Stadlbauer: Muenchgstettner
Alan S. Craig: Eric
Apesanahkwat: Arnie (lo sceriffo)
Ronald Lee Jarvis: Ron
Mark Daneri: Mark
Ray Young: Ray
Gary Lee Davis: Gary
Regia Percy Adlon
Soggetto Percy Adlon
Sceneggiatura Eleonore Adlon, Percy Adlon, Christopher Doherty
Produttore Eleonore Adlon, Percy Adlon, Dietrich von Watzdorf
Fotografia Bernd Heinl
Montaggio Norbert Herzner
Musiche Bob Telson, Johann Sebastian Bach
Scenografia Bernt Amadeus Capra
Costumi Regine Bätz, Elizabeth Warner
Trucco Lizbeth Williamson

Le due protagoniste del film scherzano durante le riprese

CCH Pounder e Jasmin Muenchgstettner
1 Bavarian Film Awards: migliore sceneggiatura (1988)
1 Ernst Lubitsch Awards: miglior regia (1988)
2 German Film Awards: migliore attrice, miglior forma di lungometraggio (1988)
1 Seattle International Film Festival: miglior film (1988)
1 Casting Society of America: miglior casting (1989)
2 Premi César 1989: miglior film straniero, miglior film dell’Unione europea
1 French Syndicate of Cinema Critics: miglior film straniero (insieme a The Dead – Gente di Dublino di John Huston) (1989)
1 Guild of German Art House Cinemas: miglior film tedesco (1989)
1 Guldbagge Awards: miglior film straniero (1989)
1 Premio Robert: miglior film straniero (1989)
1 Amanda Awards: miglior lungometraggio straniero (1989)
Shining
Nel periodo compreso tra il 1971, data d’uscita di Arancia meccanica (A clockwork orange) e il 1980 in cui esce l’ennesimo capolavoro di Kubrick, questo Shining (di cui parlerò fra poco), il grande regista di New York naturalizzato inglese gira solo Barry Lindon (1975); in tutti e tre i casi si tratta di trasposizioni di opere letterarie, visto che A clockwork orange è tratto dall’omonimo romanzo di Anthony Burgess, Barry Lindon dal romanzo di William Makepeace Thackeray Le memorie di Barry Lyndon mentre Shining dal romanzo omonimo di Stephen King.
La leggendaria pigrizia e l’altrettanto leggendario perfezionismo del regista trovano in Shining un’applicazione letterale di quelli che possono sembrare difetti ma che in realtà sono il grande valore aggiunto dell’intera opera di Kubrick.
Che non amava improvvisare, che voleva assolutamente sperimentare e che quando girava una scena era capacissimo di ripeterla all’infinito, fin quando non era moderatamente soddisfatto del risultato.
Ho scritto moderatamente perchè Kubrick in realtà sembrava eternamente scontento, anche quando la scena girata era praticamente perfetta.
In Shining il perfezionismo di Kubrick trova la sua massima applicazione principalmente nell’ossessivo rifacimento di scene girate con protagonista l’attrice Shelley Duvall che nel film interpreta Wendy Torrance;l’attrice di Houston alla fine rischiò un esaurimento nervoso ma consegnò alla storia un ritratto femminile ingenuo e terrorizzato che è da considerare come una delle vette più altre della storia della recitazione femminile nel cinema.
Kubrick quindi gira Shining (letteralmente “luccichio”) nel 1980, usando il romanzo di Stephen King come base per la sua riduzione cinematografica e allontanandosene quel tanto da costringere il romanziere di Portland a dichiarare sprezzantemente che Kubrick aveva snaturato il romanzo, attirandosi la contro risposta critica del regista che dichiarò che il romanzo in fondo “non era un granchè”

Wendy, Danny e Jack Torrance in viaggio verso l’Overlook hotel
Kubrick quindi modifica la struttura narrativa del romanzo, aggiungendo scene e tagliandone altre, modificando l’età dei protagonisti e variando il finale, pur rispettando in fondo l’impianto narrativo; consegnando però alla storia del cinema un film difficilmente inquadrabile in un genere predefinito e proiettando in esso una serie di strane disattenzioni e contraddizioni temporali che appaiono fatte a bella posta, quasi a voler rimarcare la scelta del regista di creare un’opera che mescolasse casualmente elementi horror, thriller e metafisici, in un cocktail che barcolla più volte ma che alla fine consegna alla storia un film memorabile e degno di entrare tra i primi dieci della storia del cinema stesso.
Cercare di raccontare la trama in maniera organica è davvero impresa improba; chiunque non abbia visto il film rischia di rimanere spiazzato davanti alla descrizione di quelle che sembrano in prima apparenza una sequenza di scene poco allacciate l’una all’altra. In realtà quello che va preventivata è la necessità di liberarsi dell’impressione ricavata dalla lettura del romanzo di King, in quanto Kubrick realizza qualcosa di completamente diverso, un’opera in puro stile metafisico.
Il film inizia con il colloquio tra Jack Torrance, uno scrittore in profonda crisi con problemi di alcolismo e di disoccupazione e un uomo che gli prospetta la possibilità di trasferirsi in un hotel del Colorado, sperduto tra le montagne con l’incarico di diventarne il guardiano.
L’Overlook hotel è infatti chiuso per l’arrivo della stagione invernale, essendo in pratica irraggiungibile per neve durante i cinque mesi più duri dell’anno, quando le tempeste di neve e il freddo lo rendono in definitiva un eremo isolato.
Con molta onestà, Stuart Ullman direttore dell’hotel informa Jack delle difficoltà psicologiche e di adattamento al lavoro legate al lungo periodo d’isolamento che in passato hanno causato una tragedia all’interno dell’Overlook. Il precedente guardiano, Delbert Grady, in preda ad un raptus di follia aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia.

Per nulla intimorito dal racconto, Jack accetta il lavoro e caricata l’auto e la sua famiglia, ovvero la moglie Wendy e il figlio Danny, parte alla volta del Colorado.
L’arrivo della famiglia sembra tranquillo, e il piccolo Danny lega subito con Mr. Halloran, cuoco dell’albergo; l’uomo intuisce immediatamente che il piccolo Danny è un bambino speciale. Possiede, come lui del resto, il dono della “lucciccanza”, lo shining, cioè la capacità di vedere passato e futuro, di poter anche interagire con le ombre e i fantasmi che inevitabilmente compongono questo mondo parallelo legato però in maniera fortissima al mondo reale.
 Shelley Duvall, Wendy Torrance
Shelley Duvall, Wendy Torrance
Contemporaneamente però Halloran invita il bambino a non aver paura di quello che vedrà, in quanto le immagini e le visioni non sono in grado di potergli fare del male.Nel corso del colloquio l’uomo raccomanda al ragazzino di non entrare mai e per nessun motivo nella camera 237, lasciando sospesa qualsiasi spiegazione in merito al consiglio dato.
Nei giorni successivi Danny si dedica a lunghe esplorazioni dell’albergo con il suo inseparabile triciclo, mentre sua madre Wendy passa il tempo svolgendo faccende domestiche e suo padre Jack sembra aver ripreso di buona lena la stesura del romanzo a cui stava lavorando.
Poco alla volta però l’atmosfera cambia e il piccolo Danny è il primo a notare la strana e opprimente atmosfera che aleggia nell’Overlook hotel; minacciose e inspiegabili visioni iniziano a perseguitarlo, come l’incontro con le figlie di Delbert Grady uccise anni prima, accompagnate da orribili scene in cui si vede un’ascensore spalancare le porte e far uscire un mare di sangue. Per fortuna il ragazzino, memore degli insegnamenti di Halloran, riesce a dominare la paura, evitando contemporaneamente di raccontare l’accaduto ai genitori.
L’atmosfera vira decisamente verso l’ossessivo e il claustrofobico e a farne le spese è proprio Jack, che inizia a mostrare evidenti segni di squilibrio; lo vediamo infatti dialogare con un immaginario barman dell’hotel al quale inizia a confidare i problemi personali con l’alcolismo e con la violenza che in precedenza, dapprima latitante, era esplosa un giorno nei confronti del figlio Danny al quale aveva finito per rompere un braccio.
Intanto Danny scopre cosa c’è nella camera 237; quando esce dalla stessa, il ragazzino è scosso e sua madre Wendy scopre che lo stesso presenta vistosi lividi sul collo. Se la donna dapprima pensa che la causa sia suo marito, ben presto deve ricredersi e iniziare a pensare che nell’hotel stia accadendo qualcosa di grave.Anche Jack entra nella stanza “proibita” e si ritrova davanti una splendida donna nuda che però ben presto si trasforma in un’orribile megera.
La situazione precipita; Jack parla con quella che è evidentemente una proiezione metafisica di Grady che lo invita a fare la stessa cosa che fece lui alla sua famiglia, mentre Wendy scopre un con terrore che il romanzo che suo marito sta scrivendo in realtà non è mai stato nemmeno iniziato. nella macchina per scrivere infatti la donna scopre un foglio sul quale è ripetuta ossessivamente la stessa frase, “Il mattino ha l’oro in bocca”, così come su tutti i fogli che giacciono sulla scrivania.
Ormai convinta che il marito sia fuori di testa, Wendy affronta Jack ma deve fuggire terrorizzata perchè Jack ormai completamente impazzito emulo di Grady la insegue con un’ascia tra le mani.
Danny riesce a sottrarsi al pazzo Jack e si infila nel labirinto dell’hotel che conosce alla perfezione e riesce a mimetizzarsi grazie anche all’astuto espediente di cancellare le proprie impronte.
Jack, che nel frattempo ha ucciso a colpi di scure Halloran tornato all’hotel insegue il figlio, ma persosi nel labirinto, muore assiderato….
Shining è sostanzialmente un film con più metodi di lettura; chiunque può riconoscere nella riduzione di Kubrick un’allegoria della follia che alberga negli individui di età adulta, oppure una semplice allucinazione portata oltre i confini della razionalità oppure una qualsiasi chiave di lettura che la sensibilità dello spettatore può suggerire.
 L’ombra della follia nello sguardo di Jack
L’ombra della follia nello sguardo di Jack
In fondo quello che Kubrick fa è esattamente questo, offrire allo spettatore un modo alternativo di vivere una vicenda in cui la follia e l’invisibile, le proiezioni mentali e le malattie stesse della mente, la nemesi di un destino che si ripropone oppure semplicemente una maledizione che stagna nell’Overlook Hotel come una malattia virale sono parte integrante di una storia ai limiti del credibile eppure così semplice nella sua linearità da rendere quasi banale l’effetto male/ follia che si scatenano nell’angoscioso hotel.
Un film molto bello e kafkiano, in cui la mano di Kubrick è evidentissima in ogni dettaglio e in cui però va citato l’altro elemento fondamentale che ha contribuito allo straordinario successo di critica e di pubblico del film, la recitazione di uno straordinario o superlativo Jack Nicholson, capace di rendere demoniaco in maniera eccelsa il personaggio folle e drammatico di Jack Torrence.
Accanto a lui, assolutamente inimitabile, uno dei più grandi attori della storia del cinema, va citata Shelley Duvall, che probabilmente arrivò ad odiare Kubrick ma che ottenne grazie a questo film una notorietà che altrimenti avrebbe faticato per avere.
L’edizione italiana del film ha anche un punto di forza, ovvero lo splendido doppiaggio fatto dalla coppia Giannini-Giampalmo, coppia anche nella vita, che prestano la voce ai conosciutissimi e ormai inconfondibili Jack e Wendy.
Da segnalare anche l’uso della camera a mano, che da ancor più drammaticità all’immagine, una soluzione tecnica che diverrà in seguito uno dei cardini della cinematografia moderna.
Shining può quindi essere definito un capolavoro, in un genere che non ha mai avuto il favore della critica, quello dell’horror/thriller; tocca proprio a Kubrick quindi arrivare per primo all’olimpo dei registi più apprezzati, anche se per una sola opera di un genere da sempre poco considerato.
Il vero genio è questo, ovvero l’uomo che innova e modifica, crea e taglia per montare, smontare e rimontare ossessivamente, mai pago del risultato finale; fatte le ovvie e debite proporzioni, Kubrick assomiglia ad un altro genio che aveva le stesse caratteristiche, Leonardo Da Vinci.
Il grande toscano non era mai soddisfatto di quello che creava, così come Kubrick.
E’ questo probabilmente il confine tra la normalità e il genio assoluto.
Annotazioni sul film
Stanley Kubrick, come già detto in fase di recensione, apportò varie modifiche alla stesura originale del romanzo di Stephen King.
Le più importanti riguardano l’età dei protagonisti; gli attori Nicholson e Duvall sono di almeno dieci anni più anziani dei loro omologhi nel romanzo, La Duvall è bruna mentre nel romanzo la protagonista è bionda, il direttore dell’hotel appare come un personaggio cordiale, nel film, mentre nel romanzo è assolutamente l’opposto,nel film Jack impugna un’ascia mentre nel romanzo una mazza da baseball e infine completamente diverso è il finale, almeno nella parte che riguarda la morte di Jack che nel romanzo di King avviene per lo scoppio di una caldaia.Infine nel libro la camera misteriosa porta il numero 217.
Kubrick tagliò quasi 25 minuti di pellicola, che nell’edizione definitiva italiana è di poco meno di 119 minuti contro i 143 originali.
La frase che Jack scrive ossessivamente scoperta da sua moglie Wendy in origine era” All work and no play makes Jack a dull boy” ovvero ” Solo lavoro e niente divertimento rendono Jack un ragazzo svogliato”, modificata nella versione italiana in Il mattino ha l’oro in bocca e che varia ancora a seconda delle nazioni in cui venne distribuito il film (in Germania “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”, in Spagna “Anche se ti alzi più presto, non farà giorno prima” e in Francia “Un «Tieni» vale più di due «Avrai»”)
Shining,un film di Stanley Kubrick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson,Philip Stone, Joe Turkel, Anne Jackson, Tony Burton, Lia Beldam, Billie Gibson, Barry Dennen, Lisa Burns, Louise Burns, David Baxt, Manning Redwood, Lia Beldman, Alison Coleridge
Titolo originale The Shining. Horror, durata 119 min. – USA 1980.
Jack Nicholson: Jack Torrance
Shelley Duvall: Wendy Torrance
Danny Lloyd: Danny Torrance
Scatman Crothers: Dick Halloran
Barry Nelson: Stuart Ullman
Philip Stone: Delbert Grady
Joe Turkel: Lloyd
Tony Burton: Larry Durkin
Barry Dennen: Bill Watson
Anne Jackson: Dottoressa
Regia Stanley Kubrick
Soggetto Stephen King (romanzo)
Sceneggiatura Stanley Kubrick, Diane Johnson
Produttore Stanley Kubrick
Fotografia John Alcott
Montaggio Ray Lovejoy
Musiche Wendy Carlos e Rachel Elkind, Bela Bartok, Krzysztof Penderecki, Gyorgy Ligeti
Scenografia Roy Walker
Doppiatori:
Livia Giampalmo: Wendy Torrance
Davide Lepore: Danny Torrance
Giancarlo Giannini: Jack Torrance
Marcello Tusco: Dick Halloran
Pietro Biondi: Stuart Ullman
Gianni Bonagura: Delbert Grady
Roberto Herlitzka: Lloyd

“Sono il lupo cattivo!”
“Wendy dammi la mazza”
“Wendy, forse è bene che tu sappia che… quando passi da queste parti e mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione, mi distrai capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo! Sono chiaro?”
“Ciao, Danny. Vieni a giocare con noi? Vieni a giocare con noi, Danny? Per sempre… per sempre… per sempre.”
“Wendy, tesoro, luce della mia vita! Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto, quella testa te la spacco in due, quella tua testolina te la faccio a pezzi!”

Tre versioni internazionali del libro di King

L’Overlook Hotel: sullo sfondo il monte Hood

Una splendida immagine del monte Hood

La neve sommerge l’Overlook hotel

L’Overlook hotel, in realtà il Timberline Lodge sul monte Hood in Oregon

Una vecchia cartolina antecedente al film di Kubrick